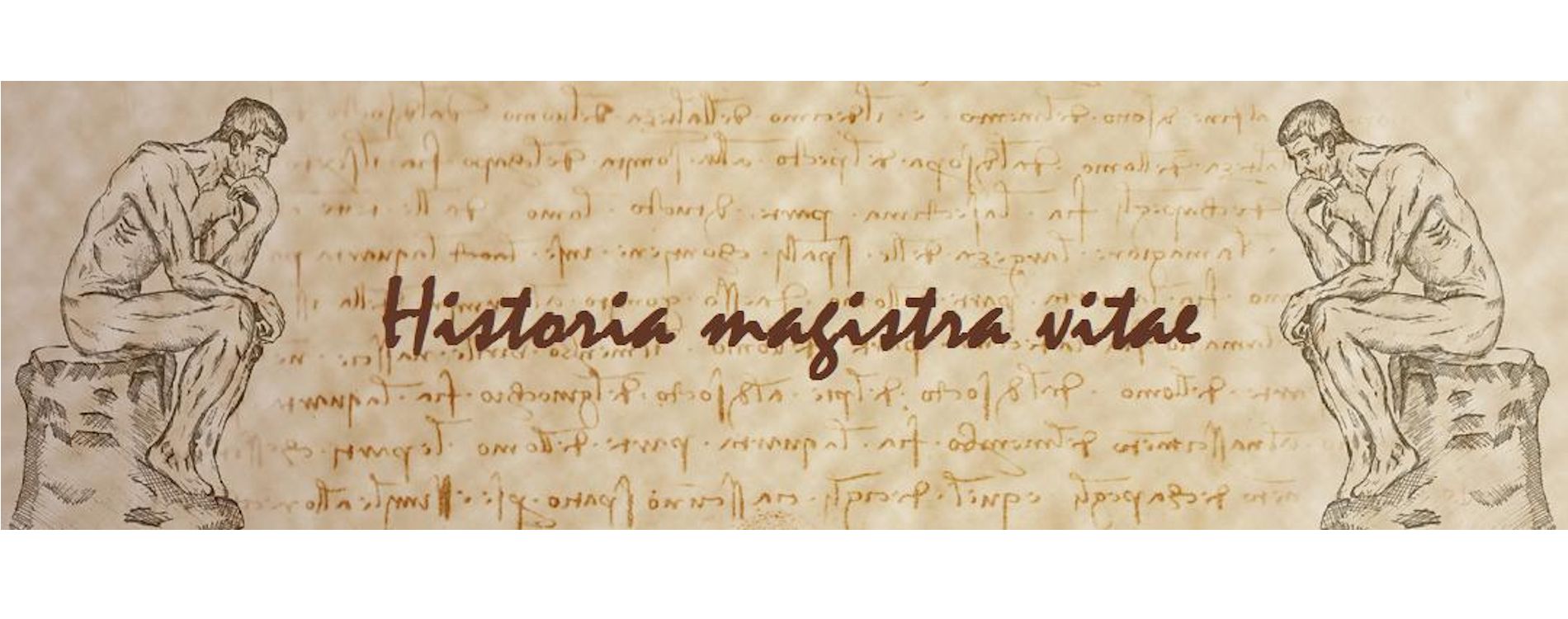Cap. 1.: Introduzione: Atene tra mito e storia
Ma il mito di Atene, grazie soprattutto alla mediazione delle scelte bibliotecarie di Alessandria e alla forza della cultura romana alla fine ha vinto.
Pag. 9
La forza di quel mito sta nella duplicità di piani su cui è possibile ed è giusto leggere l’epitafio pericleo.
E’ evidente, infatti, che svincolato dalla situazione concreta (l’epitafio discorso falso per eccellenza) e dalla concreta vicenda dei protagonisti (Pericle princeps in primo luogo), quella immagine di Atene è, comunque, fondata, e perciò ha retto e alla fine ha vinto.
Ma il paradosso è che quella grandezza che il Pericle tucidideo delinea – e che era vera già allora – era l’opera essenzialmente di quei ceti alti e dominanti che il ‘popolo di Atene’ tiene sotto tiro e, quando possibile, abbatte e perseguita.
E il Pericle ‘vero’ questo lo sapeva benissimo e lo aveva vissuto e patito in prima persona.
La grandezza di quel ceto consistette nel fatto di aver accettato la sfida della democrazia, cioè la convivenza conflittuale con il controllo ossessivo occhiuto e non di rado oscurantista del “potere popolare”: di averlo accettato pur detestandolo, com’è chiaro dalle parole dette de Alcibiade, da poco esule a Sparta, quando definisce la democrazia “una follia universalmente riconosciuta come tale”.
Pag. 10
L’acrimonia con cui Aristofane nelle Nuvole rappresenta quel mondo elitario, con Socrate al centro, davanti al suo pubblico, in cui prevaleva certamente il tipo dell’”Ateniese medio”, dimostra – come del resto il Socrate platonico dichiara apertamente nell’Apologia – che l’”Ateniese medio” detestava e guardava con sospetto quel mondo: dal quale per lo più provenivano le persone che erano (a rotazione e conquistandosi il consenso) a capo della città.
Aristofane sta in bilico tra questi due importanti soggetti sociali: è il mestiere che si è scelto a porlo in bilico; se non fosse stato così, il suo lavoro artistico sarebbe andato incontro al fallimento.
Perciò è così complicato cercar di definire ‘il partito’ di Aristofane.
Pag. 11
Il ‘miracolo’ che quella straordinaria élite ha saputo compiere, governando sotto la pressione non certo piacevole della ‘massa popolare’, è stato di aver fatto funzionare e prosperare la comunità politica più rilevante del mondo delle città greche e, ciò facendo, aver modificato almeno in parte, nel vivo del conflitto, se stessa e l’antagonista.
Questo lo si capisce bene studiando l’oratoria attica, ove si può osservare come la parola dei ‘signori’ – i soli la cui parola ci è nota – si impregni di valori politici che sono di base nella mentalità combattiva e rivendicativa della ‘massa popolare’: innanzi tutto to ison, ciò che è uguale e, quindi, giusto.
Lo si è visto – all’inizio – ripercorrendo i motivi cardine dell’epitafio pericleo.
Del quale si coglie solo in parte il senso se ci si limita a constatare quanto esso sia limitrofo della parola demagogica.
Pag. 13
Da questa duplicità di piani discendono i due tempi della storia di Atene: da un lato il tempo storico e contingente, che è quello di una esperienza politica che – così com’era nella sua contingente storicità – si è autodistrutta, e dall’altro il tempo lunghissimo, che è quello della persistenza nei millenni delle realizzazioni di quell’età frenetica.
E ci si potrebbe spingere oltre, osservando che se Atene funzionò così, se produsse tanto perché una élite aperta accettò la democrazia, cioè il conflitto e il rischio costante della sopraffazione, allora ciò significa che, a sua volta, anche quel meccanismo politico, per la cui definizione tanto si sono affannati e inquietati gli interpreti (da Cicerone a George Grote o a Eduard Meyer), recava dentro di sé due tempi storici: quello ut nunc di cui l’opuscolo di Crizia è solo in parte una caricatura e, per altro verso, il valore inestimabile del conflitto come detonatore di energia intellettuale e di creatività durevole, che è forse il vero lascito di Atene e l’alimento legittimo del suo mito.
Pag. 14-15
Cap. 2. Lotta intorno a un mito
Come è noto, l’impero ateniese ebbe origine da una iniziativa degli isolani che maggiormente avevano collaborato, nei limiti delle rispettive forze, alla vittoria nella guerra navale contro i Persiani (480. A. C.).
Creazione della flotta, voluta con lungimiranza da Temistocle, costruzione tumultuaria delle “grandi mura” miranti a trasformare Atene in una fortezza con un magnifico sbocco al mare, e nascita di una lega inizialmente di tipo paritario (‘Atene e gli alleati’ con il tesoro federale sistemato nell’isola di Delo) sono azioni concomitanti che segnano l’inizio del secolo ateniese, di cui la vittoria a Maratona dieci anni prima era stata solo un antefatto (passibile, allora, anche di altri sviluppi).
Come il ventesimo secolo incomincia col 1914 così il quinto secolo incomincia con Salamina e la nascita dell’impero ateniese: destinato a durare per poco più di settant’anni, fino al crollo del 404 e la riduzione di Atene, priva ormai di mura e senza flotta, a mero satellite di Sparta.
Pag. 16
La giustificazione dell’impero in ragione della vittoria sui Persiani ha avuto una lunga storia.
Quando Isocrate la riprende è pura ideologia: l’attacco verso Oriente è fuori dell’orizzonte ateniese (e di ogni altra potenza greca).
La seconda lega naufragherà dopo trent’anni in una logorante guerra tra Atene e gli alleati (la ‘guerra sociale’: 357-355); di lì a qualche anno, guidata da Demostene, Atene cercherà l’aiuto persiano contro la Macedonia e alla fine sarà proprio la Macedonia a scatenare l’attacco decisivo a Oriente e porterà in pochi anni alla dissoluzione dell’impero persiano (334-331 a. C.).
E nondimeno il mito di Atene liberatrice dei greci perché vincitrice dei persiani funzionava ancora quando Demostene – nel 340/339 – cercava di giocare, con disinvoltura realpolitica, la carta persiana, scontrandosi in assemblea, ancora alla vigilia di Cheronea, contro il radicato mito del “nemico tradizionale dei greci” e perciò “immutabile avversario di Atene”.
Pag. 19
Ma Filippo non ha invaso l’Attica, come pure si era temuto all’annuncio della sconfitta; ha cercato il compromesso.
Ha dato corpo ad una sua “pace comune”, col trattato di Corinto (336).
Sapeva di aver vinto ma non era certo di aver fiaccato definitivamente Atene.
Non deve perciò sorprendere che, qualche decennio più tardi, quando ormai la fine dell’impero persiano ad opera di Alessandro aveva cambiato la faccia del mondo, purtuttavia, alla notizia della morte di Alessandro Atene è stata in grado di mobilitare daccapo una coalizione panellenica che fu per qualche mese (323-322: la cosiddetta “guerra lamiaca”) in grado di mettere a rischio il predominio macedone in Europa.
E’ con la fine della guerra lamiaca, più che con Cheronea, che finisce la storia di Atene come grande potenza.
Pag. 27
La verità storica cede il passo alla necessità, immediata, urgente, di disegnare con nettezza il ritratto del nemico.
A questo punto al feroce lotta per l’egemonia durata oltre un secolo diventa una gara cavalleresca in cui le potenze si scontravano “pur non avendo in origine torti reciproci di cui dolersi” ma per il dovere di “riparare torti inflitti ad altri”.
Ed in questa gara, mentre quella tebana sfuma quasi nel nulla; e perché Sparta, come già argomentava Isocrate nel Panegirico, ha commesso più ingiustizie nella sue breve egemonia che non Atene nei suoi oltre settant’anni.
Il lettore rischia quasi di crederci.
In questa pagina è come se la storia conosciuta incominciasse con l’egemonia ateniese, con l’impero, e non ci fosse invece una lunghissima fase precedente nella quale la potenza regolatrice degli equilibri era stata Sparta.
Ma Sparta non aveva saputo, o voluto, esportare il suo “mito”.
Cap. 3. Un mito tra i moderni
Della nascita e dello sviluppo dell’Impero ateniese avevamo una descrizione sintetica e severa nel primo libro di Tucidide, al principio del suo excursus sul ‘Cinquantennio’ intercorso tra la vittoria di Salamina (480) e lo scoppio della lunga guerra contro Sparta e gli alleati (431).
Lì Tucidide spiega in brevi tratti come si era prodotta la torsione in senso imperiale dell’alleanza sorta sull’onda del successo ateniese contro la Persia.
Ma l’attenzione dello storico e del politico è rivolta soprattutto al rapporto sempre più diseguale tra Atene e gli alleati, non però alla parallela e conseguente trasformazione del “popolo di Atene” in cero privilegiato all’interno della realtà imperiale considerata nel suo complessivo e unitario funzionamento.
Pag. 31
E’ la città dove si pratica la censura: e la vittima è nientemeno che Socrate.
“Défions nous, messieurs, de cette admiration pour certaines réminiscences antiques!”.
Insomma, la polarità che vorrebbe istituire tra una libertà oppressiva (cioè la democrazia antica) e la libertà libera dei moderni (da lui auspicata e che, incauto, vede finalmente realizzata nella Francia di Luigi 18.) gli si sfascia quando si tratta di Atene.
E’ lì che il suo teorema si inceppa perché Atene è le due cose assieme, come si evince del resto dall’epitafio pericleo-tucidideo, a saperlo leggere.
Pag. 38
Negli anni Sessanta del 5. secolo tutta la popolazione povera di Atene si strinse attorno a un partito unitario con lo scopo di impossessarsi del potere politico.
Alla guida si pose Efialte, un uomo la cui personalità sappiamo purtroppo assai poco, ma che certamente è da considerarsi tra le più spiccate intelligenze politiche dell’antichità.
Bastava in fondo un unico provvedimento per rovesciare l’ordine esistente e sostituire il potere del proletariato a quello della borghesia: si doveva far decadere il principio, in virtù del quale l’attività svolta in Consiglio e presso i tribunali era considerata solo onorifica.
Appena a un membro del Consiglio o a un giudice popolare fosse stata pagata una diaria che gli avesse consentito di vivere, sarebbero cadute le barriere che sino ad allora avevano tenuto i proletari lontani da una partecipazione attiva alla vita pubblica.
Solo così si sarebbe veramente salvaguardato il principio dell’elezione a sorte introdotto dalla repubblica borghese.
Ora, in tutte le circoscrizioni dello Stato i cittadini poveri erano assai più numerosi dei ricchi e la semplice applicazione del sorteggio avrebbe perciò determinato necessariamente nel Consiglio e nei tribunali una maggioranza di poveri.
Raggiunto questo obiettivo, tutto il resto sarebbe venuto da sé.
Pag. 41-42
Se non aspiravano al socialismo, ancor meno i proletari ateniesi pensavano all’abolizione della schiavitù.
Già prima abbiamo sottolineato come non esistesse che in modo irrilevante un sentimento di solidarietà tra i greci liberi e gli schiavi importati dai paesi barbari.
Il proletariato ateniese, appena assunto il potere, si preoccupò comunque di garantire legalmente agli schiavi un trattamento più umano, e questo provvedimento resta pur sempre a gloria dei cittadini poveri di Atene.
La totale abolizione della schiavitù, sarebbe stata di scarsa utilità pratica per i cittadini nullatenenti.
Per quanto riguarda Atene non abbiamo notizia che esistesse disoccupazione tra i liberi, e, come diremo più avanti, i salari dei lavoratori liberi qualificati erano abbastanza alti al tempo della dittatura del proletariato, e perciò non è ipotizzabile che con l’abolizione della schiavitù essi sarebbero ulteriormente cresciuti.
Pag. 42-43
Riassumendo, possiamo dire che l’antica polis costituì, dopo la creazione della disciplina degli opliti, una corporazione di guerrieri.
Ovunque una città voleva seguire una politica attiva di espansione sul continente, essa doveva seguire in misura più o meno grande l’esempio degli spartani, vale a dire formare gli eserciti di opliti addestrati traendoli dai cittadini.
Anche Argo e Tebe crearono all’epoca della loro espansione dei contingenti di guerrieri specializzati – a Tebe legati ancora dai vincoli della fratellanza personale.
Le città che non possedevano truppe di questo genere, come Atene e la maggior parte delle altre, erano sul terreno costrette alla difensiva.
Dopo la caduta delle schiatte (gene) gli opliti cittadini costituirono però ovunque la classe decisiva tra i cittadini di pieno diritto.
Questo strato non trova nessuna analogia né col Medioevo né in altra epoca.
Anche le città greche diverse da Sparta avevano, , in grado più o meno rilevante, il carattere do un accampamento militare permanente.
Perciò, agli inizi della polis degli opliti, le città avevano sviluppato sempre più l’isolamento verso l’esterno, in antitesi con l’ampia libertà dei movimenti dell’epoca di Esiodo: e molto spesso sussistevano limitazioni all’alienabilità dei lotti di guerra.
Ma questa istituzione scomparve già per tempo nella maggior parte delle città, e diventò del tutto superflua quando assunsero importanza predominante sia i mercenari ingaggiati sia, nelle città marittime, il servizio nella flotta.
Ma anche allora il servizio militare rimase in ultima analisi decisivo per il dominio politico nella città, e questa conservò il carattere di una corporazione militaristica.
Verso l’esterno, fu proprio la democrazia radicale di Atene ad appoggiare quella politica espansionistica che, abbracciando l’Egitto e la Sicilia, aveva quasi del fantastico in relazione al limitato numero degli abitanti.
Verso l’interno la polis, quale gruppo millenaristico, era assolutamente sovrana.
La cittadinanza disponeva a suo arbitrio del singolo individuo sotto ogni aspetto.
La cattiva amministrazione domestica, specialmente lo sperpero del lotto di terra ereditato (i bona paterna avitaque della formula di interdizione romana), l’adulterio, la cattiva educazione dei figli, il maltrattamento dei genitori, l’empietà, la presunzione – cioè in genere ogni comportamento che metteva in pericolo la disciplina e l’ordine militare e cittadino, e che poteva eccitare la collera degli dei a danno della polis – venivano duramente puniti, nonostante la famosa assicurazione di Pericle nell’orazione funebre di Tucidide, secondo la quale ad Atene ognuno poteva vivere come voleva.
Pag. 44-45
Ciò che accadde ad Atene alla fine del 5. secolo non si ripeté altrove, perché soltanto Atene offriva la necessaria combinazione di elementi: sovranità popolare, un gruppo ampio e attivo di pensatori vigorosamente originali e le esperienze uniche provocate dalla guerra.
Proprio le condizioni, insomma, che attiravano ad Atene le menti migliori della Grecia potevano metterle, e le misero per un certo tempo, in una situazione singolarmente precaria.
Atene pagò un prezzo terribile: la maggiore democrazia greca diventò soprattutto famosa per avere condannato a morte Socrate e per aver allevato Platone, il più vigoroso e il più radicale moralista antidemocratico che il mondo abbia mai conosciuto.
Pag. 45
La discussione su Demostene e Filippo, assunti quasi a metafora di conflitti attuali, si era sviluppata anche in Italia.
Il Demostene di Piero Treves (1933) ed il Filippo il Macedone (1944) di Arnaldo Momigliano rendono bene questa polarità.
Proprio dall’ambiente del fascismo culturale italiano venne il più duro attacco contro Jaeger.
E’ la lunga e aspra recensione scritta da Gennaro Perrotta sulla rivista del ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai “Primato”.
Lì viene messo sotto accusa il “classicismo”, che ha consacrato a Demostene “un culto eroico”, viene definito il libro di Jaeger “prova della funesta immortalità del classicismo”, sbeffeggiato Piero Treves come autore di “uno sconclusionato libretto su Demostene e la libertà dei Greci”, vilipeso il concetto di libertà come autonomia, esaltata la “necessità e razionalità della storia” che sta alla base del trionfo di Filippo contro la “libertà grettamente municipale di Atene”.
Il tutto nel nome di Droysen, di Beloch e della vera politica “che non sa che farsi della rettorica”.
Il tono è sovraeccitato e trasparentemente politico: Treves, come ebreo, aveva dovuto riparare in Inghilterra per le leggi razziali del 1938, e la guerra hitleriana stava facendo strame della “libertà come autonomia”.
Non è senza significato che, della traduzione italiana del Demostene di Jaeger (Einaudi, 1942), l’autore nonché collaboratore di Calogero sua rimasto anonimo.
Pag. 49-50
Sorge perciò la domanda: come mai, nonostante i vincitori fossero stati i macedoni e nonostante proprio grazie a loro e alle loro istituzioni culturali (Alessandria etc.) la cultura greca si fosse salvata nei secoli che precedono l’egemonia romana, nondimeno alla fine era stata l’immagine di Demostene che aveva prevalso, così come quella dell’Atene classica?
Sì che c’era voluto, millenni dopo, un Droysen per capovolgerla e lanciare la visione dell’Ellenismo come epoca positiva, come lunghissima fase positiva della Weltgeschichte.
(Nel mai realizzato disegno droyseniano, l’Ellenismo andava considerato nel suo sviluppo storico almeno fino all’Islam).
Il ripristino del primato dell’Atene classica fu dovuto essenzialmente ai romani.
Furono i romani, i quali per dominare davvero il Mediterraneo dovettero abbattere non solo Annibale ma soprattutto la ferrea e armatissima monarchia macedone, a ‘declassare’ il ‘nemico’, e ad esaltare – in un misto di idealizzazione letteraria e sterilizzazione politica – Atene, il suo mito e la sua centralità.
Declassarono i macedoni in favore del proprio ruolo imperialistico e inventarono, si potrebbe dire, il ‘classicismo”, di cui Atene era il focus: dunque il contrario dell’Ellenismo.
Che Atene potesse anche diventare un modello politicamente pericoloso, come quando il cesaricida Marco Giunio Bruto arruolava ‘repubblicani’, uno dei quali era il povero Orazio, tra la gioventù studiosa che frequentava le scuole della città-museo, non costituiva un vero rischio.
E poi s’era visto al tempo di Silla cosa i romani erano capaci di fare ad Atene se mai fosse apparsa militarmente fastidiosa, come accadde nell’ultimo sussulto di autonomia politica, quando Atene si schierò con Mitridate.
Il mito letterario-museale di Atene, culla del classicismo, durava e fioriva ancora al tempo di Adriano.
Non erano certo valse le opzioni di Cesare, e soprattutto di Antonio, in favore dell’ultima monarchia ellenistica, quella di Cleopatra, ad intaccare la scelta fondamentale.
Anzi, se Cicerone traduceva la Corona demostenica, nelle scuole di retorica si elaboravano declamationes che scongiuravano Alessandro di non voler superare i confini del mondo.
Pag. 52
Cap. 4. Una realtà conflittuale
Il conflitto domina la vita ateniese in ogni suo aspetto.
Il teatro mette in scena, per sua stessa natura, genesi, finalità e struttura, il conflitto.
Il tribunale – che ben più dell’assemblea è il luogo dove si esplica capillarmente e direttamente la democrazia – è, e non può non essere, conflitto: le Vespe aristofanee in tanto mordono come satira in quanto si riferiscono ad una realtà primaria delle vita cittadina.
L’assemblea è la sede ufficiale dello scontro, aspro e continuo, beninteso se il contesto è la democrazia.
Ed è dal conflitto tra gli opposti valori delle aristocrazie per un verso e del demo per l’altro che si mette in moto il pensiero etico.
Nella polis, spazio limitato, il possesso della piena cittadinanza è il bene più conteso: quando il conflitto degenera in guerra civile il primo intervento è la limitazione della cittadinanza.
E la guerra come forma normale di risoluzione dei conflitti unifica in un coerente atteggiamento d’insieme questo modo di essere.
“Ares cambiavalute di corpi umani che regge la bilancia dello scontro – canta il coro dell’Agamennone di Eschilo – […] rimanda ai parenti polvere lacrimata e arsa, colmando di cenere, in cambio di uomini, vasi funerari, carico maneggevole”.
Secondo Platone, nelle Leggi, gli spartani lo sanno da sempre: sono allevati secondo l’assioma “che tutti devono condurre durante la loro vita una guerra perpetua contro tutte le città”.
La morte politica domina l’esperienza ateniese sin dal principio.
E’ un carattere di cui cogliamo le remote matrici nella grecità arcaica.
Che l’Iliade, cioè il racconto aspro di una guerra di rappresaglia con le sue infinite e minuziose descrizioni di morte, e l’Odissea, il cui culmine è un massacro per vendetta, siano stati da molto presto i testi fondativi e formativi è segno di una visione cupa e conflittuale della convivenza che segna in modo durevole quelle società.
La centralità della guerra d’altra parte è inerente a tali società in quanto strumento primario per la cattura di oro e di schiavi, cioè delle forme primarie e basilari di ricchezza e di produzione (la schiavitù).
La retorica della guerra, il dovere della guerra, la pratica della guerra come strumento di selezione e accertamento del valore e definizione delle gerarchie investe la poesia come anche l’arte figurativa.
Tirteo, Callino, Archiloco stesso ne parlano come dell’ovvio habitat del maschio, cioè, nella visione arcaica, del principale fattore e attore della storia.
L’educazione parte dal presupposto che “è bello (kalon) morire combattendo in prima fila”.
Dare la morte e riceverla sembra qui la forma privilegiata di comunicazione.
Al ritorno dalla lunghissima guerra intorno a Troia i guerrieri greci vengono coinvolti in una serie di “rese dei conti” di carattere politico-passionale, che si traducono, per esempio, nel caso di Agamennone, in una serie di omicidi a catena, e nel caso di Odisseo in una vera e propria strage.
Pag. 54-55
Ma neanche gli avversari avevano la mano leggera.
I siracusani, sconfitta la grande armata ateniese, gettarono a morire nelle latomie centinaia di prigionieri ateniesi (413 a. C.).
Lisandro, dopo la vittoria decisiva contro Atene ad Egospotami (405 a. C.) fece gettare in acqua centinaia di prigionieri ateniesi.
Il crollo demografico del mondo greco al passaggio dal quinto al quarto secolo si spiega anche così.
Per comprendere la portata e il costo umano di tutto ciò conviene ricordare che la guerra è, nel mondo antico, la norma nelle relazioni internazionali, la pace è l’anomalia: perciò nei trattati di pace viene indicata la durata prevista.
Sono paci ‘a tempo’ e quasi sempre il tempo scade molto prima del previsto; la rottura del trattato di pace si produce ben prima.
La pace è dunque, al più, una lunga tregua: e la parola che designa la pace è la stessa che significa ‘tregua’: spondai.
E’ dunque facile comprendere che decenni e decenni di conflittualità diffusa che sfocia periodicamente in grandi ‘guerre generali’ hanno determinato un declino demografico inarrestabile, cui ha contribuito in grande stile la gestione miope del diritto di cittadinanza, come ben dice l’imperatore Claudio nell’efficace squarcio storico che Tacito gli attribuisce.
Se Sparta è un caso simile, in quanto Stato apertamente razziale, in cui la comunità ‘pura’ dominante è in guerra permanente con le etnie-classi sociali sottoposte, Atene – pur nella grande apertura dovuta ai commerci, in larga parte praticati da non-ateniesi residenti (i cosiddetti meteci) – è ugualmente ostile all’estensione indiscriminata della cittadinanza.
E ciò perché la cittadinanza comporta privilegi politici ed economici che il ‘popolo’, soggetto principale della democrazia, non intende condividere.
In questa chiusura signori e popolo – pur in conflitto su tutto il resto – sono pienamente concordi, fruitori come sono, entrambi (sia pure in diversa misura), dei vantaggi pratici della ricchezza riveniente dall’impero.
Pag. 56-57
Il profilo della storia ateniese come conflitto rischia non di rado di scivolare nella guerra civile deve incominciare con uno sguardo lungo.
Dal conflitto sociale esasperato che Solone nel 594/3 disinnescò con la seisacstheia e la svalutazione della moneta (che tagliava alla radice la massa stessa dei debiti), alla presa del potere da parte di Pisistrato (561/0), all’ambigua posizione degli Alcmeonidi - Clistene arconte sotto Pisistrato -, all’ammazzamento di Ipparco (514), all’intervento spartano (510), all’invenzione contestuale della democrazia e dell’ostracismo (508/7), al tentativo di colpo di mano di Isagora appoggiato dagli spartani contro Clistene, alla rivolta popolare che riporta Clistene al potere.
Pag. 59-60
L’eliminazione dell’avversario politico (dalla violenza fisica all’ostracismo, esilio, uccisione in una specie di gradatio: la scena politica ateniese offre esempi di tutti e tre i generi) appariva prassi non sconcertante, ma, piuttosto, drammatica prosecuzione della lotta politica.
Colpisce, in anni di molto successivi, una tremenda uscita demostenica risalente al 341, quando ormai la resa dei conti con la Macedonia si avvicinava e l’ossessione di Demostene era la ‘quinta colonna’ del sovrano macedone all’interno della città: “la lotta è per la vita o per la morte: questo bisogna capire. E quelli che si sono venduti a Filippo bisogna odiarli o ammazzarli”.
L’eliminazione fisica dell’avversario come esito del conflitto è una eventualità messa in contro, non è una situazione estranea – almeno potenzialmente – alla prassi del quotidiano scontro politico.
Pag. 63
Ma dal conflitto nasce anche il diritto, che a sua volta è figlio delle domande capitali sulla “giustizia” (to ison).
Il conflitto scaturisce infatti immancabilmente dalla aspirazione alla immediata compartecipazione, alla condivisione in parti uguali.
E dalla nozione di uguale/giusto discendono anche le questioni etiche, e anche la questione, ancor più tormentosa perché insolubile, della sofferenza del giusto e dell’indifferenza inspiegabile del divino.
In Atene tutto questo sfocia nella forma di comunicazione di massa più influente: il teatro.
Il teatro di Dioniso, dove, in un contesto politico e rituale molto suggestivo, vengono rappresentate le tragedie al cospetto dell’intera città, è il cuore della comunità.
Ciò che le persone pensano si forma a teatro, nella costante fruizione della drammaturgia, direttamente regolata dal potere pubblico: molto più che nella stessa assemblea popolare.
Qui la parola politica assume quasi sempre la forma della mediazione sospetta, mirante al risultato immediato, a strappare il consenso contingente.
Ed è dei più acculturati.
Non mira necessariamente allo scavo in direzione del vero.
E i politici che sanno bene quanti conti il teatro non solo lo tengono d’occhio ma talvolta si impegnano essi stessi direttamente come coreghi.
Temistocle arconte nel 493/492 assegna il coro al tragediografo Frinico, che mette in scena la Presa di Mileto (la triste epopea della rivolta ionica contro i persiani), nel 476 è corego ancora per Frinico che mette in scena le Fenicie (il dramma riguardava la vittoria ateniese a Salamina).
Pericle, appena venticinquenne, è corego per Eschilo, che mette in scena i Persiani.
Non tutte le implicazioni di questo gesto ci sono chiare: al di là della ovvia scelta ‘liturgica’ al servizio della città, doverosa per un politico on crescita, c’è un senso speciale (un Alcmeonide, con quel passato sospetto, che contribuisce alla celebrazione delle vittorie sui persiani), e c’è anche un prendere posizione per Temistocle (l’anno dopo colpito da ostracismo).
Tutto questo ‘funziona’ intorno al teatro.
Pag. 65-66
Cap. 5. La democrazia ateniese e i socratici
Due pensatori sono stati messi a morte dai tribunali ateniesi: Antifonte e Socrate.
Entrami erano settantenni quando bevvero la cicuta.
Il primo fu accusato di aver tradito la città complottando col nemico; il secondo di corrompere i giovani e di non credere negli dei della città.
Il primo si era a lungo astenuto dalla politica attiva e aveva deciso di impegnarsi solo quando gli parve giunto il momento e offerta la possibilità di instaurare un ordine completamente diverso da quello ‘democratico’.
Il secondo non fece mai politica, ma si trovò ad un certo momento della sua vita, dati i meccanismi affidati al cado dagli organi rappresentativi della città, alla ‘presidenza della repubblica’ (il collegio dei pritani): proprio nel giorno in cui l’assemblea, in funzione giudicante, decideva di condannare a morte i generali vincitori alle Arginuse, fu l’unico ad opporsi alla procedura illegale, e poco mancò che lo buttassero giù fisicamente dal suo seggio.
Ma alla politica come problema aveva dedicato gran parte della sua straordinaria forza critica.
Pag. 67
Cap. 6. I quattro storici di Atene
Tucidide elabora anche la teoria che dei fatti storici si possono studiare i “sintomi”.
Lo dice a proposito della ricostruzione del passato più remoto, nella cosiddetta ‘archeologia’; lo dice a proposito della stretta concatenazione, dovunque si produca un conflitto, tra guerra esterna e guerra civile; e lo riafferma, quasi negli stessi termini, quando spiega il grande spazio da lui riservato ai sintomi della peste.
Alla base c’è l’idea, mutuata dalla sofistica, della sostanziale immutabilità della natura umana.
Pag. 79
Parte prima. Il sistema politico ateniese: “Una gilda che si spartisce il bottino”.
Cap. 1. “Chi vuole parlare?”
In conclusione.
La commedia può dire molto di più di quel che si può dire nell’assemblea, ma, proprio perché parla esplicitamente, e non per metafora, della politica cittadina, non può non tener conto dei vincoli e dei limiti inerenti al funzionamento della macchina politica, non può calpestare quelle “clausole di sicurezza” (o di garanzia, come si dice nel moderno linguaggio costituzionale) con cui il sistema, nella fattispecie la democrazia assembleare, difende se stessa.
C’è del vero al di là del tono eccessivamente ammirativo, in ciò che scrive Madame de Stael su Aristofane, e il suo giudizio può valere per l’intera commedia attica ‘antica’: “Aristofane – scriveva la figlia di Necker – viveva sotto un governo talmente repubblicano che tutto veniva messo in comune col popolo, e gli affari pubblici passavano agevolmente dalla piazza delle riunioni al teatro”.
E certo il teatro è, in Atene, accanto all’assemblea e ai tribunali, un pilastro del funzionamento politico della comunità.
Sono quelle le tre sedi in cui la comunità si riconosce tale e nelle quali la comunicazione è davvero generale e immediata.
E questo è un tratto specifico di Atene.
Atene è certamente, del mondo greco, il luogo dove più largamente si consuma cultura: “un paese – ricorriamo ancora alle parole di Madame de Stael – dove la speculazione filosofica era quasi altrettanto familiare alla comune delle persone che i capolavori artistici, dove le ‘scuole’ si tenevano en plein air”.
En plein air, cioè a teatro, veniva portata in discussione, delibata e magari derisa anche l’ipotesi radicale di una società comunistica (Aristofane, Ecclesiazuse), di cui però Platone discuteva al chiuso.
Ed è degno di nota, a questo proposito, il giudizio convergente del Pericle tucidideo nell’epitafio (“siamo il luogo di educazione dell’intera Grecia”) e di Isocrate nel Panegirico, che pure su tanti punti a quell’epitafio si contrappone (“ho voluto dimostrare, con questo discorso, che la nostra città è all’origine di ogni positiva realizzazione per gli altri greci”).
Atene del resto è il luogo di maggiore alfabetizzazione: basti pensare alla assoluta prevalenza di epigrafi attiche su quelle di ogni altra provenienza per il periodo in cui Atene fu anche il rizzo Diceopoli, mentre attende che l’assemblea finalmente si popoli, scrive (“e io intanto passo il tempo a lamentarmi, a sbadigliare, a smaniare, a fare peti, a scribacchiare e a farmi dei conti”).
Pag. 86-87
Il teatro tragico molto raramente trattava materia storico-politica che potesse considerarsi attuale.
Quando nel 493 (o 492) a. C. Frinico mise in scena La presa di Mileto il pubblico ebbe una forte reazione emotiva, molti scoppiarono in lacrime.
Il poeta fu punito per aver messo in scena quella sventurata vicenda della rivolta ionica (peraltro poco efficacemente sorretta dagli ateniesi) e fu fatto divieto di portare mai più in scena quella vicenda.
Invece venti anni dopo, Eschilo, coi Persiani, che mettono in scena la sconfitta dei persiani a Salamina e la grande vittoria ateniese che fu alla base della nascita dell’impero, conseguì il successo: e corego fu Pericle, allora appena venticinquenne.
Il meccanismo di controllo sui contenuti non potrebbe essere più chiaramente illustrato.
Mettere in scena la vittoria sui persiani era qualcosa di molto simile alla pedagogia storico-politica impartita con il rito quasi annuale degli “epitafi” per i morti in guerra.
Anche negli epitafi Atene appariva sempre vittoriosa nelle guerre del passato, e sempre propugnatrice delle cause giuste, contro nemici che erano anche despoti o tiranni.
Ma, appunto, la materia storico-politica nel teatro tragico non era usuale.
Molto più usuale quella mitologica, che aveva l’enorme vantaggio della immediata comprensibilità da parte del pubblico, trattandosi di repertorio conosciuto e tradizionale, nonché il vantaggio per gli autori, della eventuale allusività di vicende remote e indiscutibili (dunque sottratte a qualunque censura) se opportunamente rivissute, riproposte, secondo una libertà nei confronti del bagaglio mitico-religioso caratteristica della religiosità greca.
“Le opere dovevano essere di grande respiro e a forti tinte per impressionare le masse” scrive Rosenberg, il quale ha il merito di mettere in luce lo stretto nesso che vi è tra la grande, enorme, massa degli spettatori e la conseguente necessità di materia semplice e nota oltre che fortemente emotiva.
La mediazione offerta dal bagaglio mitologico liberamente ripensato consentiva di esprimere valori, dunque di interloquire con la città su di un piano, in senso alto, politico, fino a prese di posizione e fino a porre domande sommamente radicali.
Questo sfuggiva a qualunque controllo preventivo di qualunque zelante arconte eponimo per quanto dotato di senso civico e per quanto fervente assertore della ‘morale media’.
Un riscontro negativo poteva venire dal pubblico, che rifiutando il premio (come lo rifiutò quasi sempre ad Euripide) mostrava di respingere questa indiretta e altamente problematica, e non di rado squassante, ‘politica’ proveniente dalla scena.
Pag. 89-90
Cap. 2. La città messa in discussione dalla scena
Esponenti dei ceti elevati, i quali pur dotati della necessaria preparazione per la politica, disertavano l’assemblea, sceglievano però di far sentire la propria voce critica attraverso il teatro, dalla scena.
Raggiungevano così un pubblico molto più vasto, a fronte dell’endemico assenteismo assembleare, e correvano molti rischi (a parte, beninteso, quello di non conseguire il premio).
Pag. 89
Orbene, con la téchne Antifonte ha fatto, nel 411, ciò che a chiunque (Tucidide compreso) sembrava una impresa impossibile: togliere di mano agli ateniesi la democrazia dopo circa un secolo di pratica ininterrotta di tale regime politico particolarmente caro al demo (cioè alla ‘maggioranza’, al più forte).
L’Antifonte che esalta, in quel trimetro, la téchne e i suoi prodigi contro la superiorità della natura, è dunque in piena sintonia con l’Antifonte tucidideo, il quale “preparandosi da moltissimo tempo” riuscì a fare quello che a chiunque sarebbe parso impossibile e che la scienza politica moderna ha definito “forza irresistibile delle minoranze organizzate”.
Pag. 94-5
Condizione dello schiavo – che ha chiara memoria di sé quando era libero -, non inferiorità del barbaro, condizione femminile, aporie della monogamia: erano temi che scalfivano in profondità le certezze etiche e sociali della città, dell’”ateniese medio” buon democratico.
E Antifonte proprio sul tema del carattere fittizio della distinzione greco-barbaro (cioè libero-schiavo) si esprimeva con forza nel trattato Sulla verità: “La verità del sofista Antifonte – scrisse Wilamowitz nel suo grande libro sulla Fede dei greci – dissolveva ogni vincolo del diritto e della morale (e del costume) in quanto tirava le conseguenze più radicali, estreme, del contrasto tra ciò che è giusto secondo natura e ciò che è giusto secondo la convenzione (“la legge”).
“Noi siamo più barbari dei barbari” – scrive Antifonte in quel frammento, restituitoci da un papiro – perché abbiamo posto un abisso “tra greci e barbari”, laddove per natura siamo uguali, “respiriamo tutti col naso e prendiamo tutti il cibo con le mani”.
Pag. 95-96
“E’ strano – commenta Wilamowitz – che uno che scriveva in questo modo sia rimasto indisturbato e non abbia dovuto andarsene”.
La questione è giusta, ma può trovare risposta proprio nell’ipotesi di un unico Antifonte.
Chi parla in quel modo, infatti, non è, necessariamente, un campione dell’uguaglianza di tutti gli uomini, addirittura “antesignano” della mentalità abrogazionista affermatasi nell’America di Jefferson o nella Francia di Robespierre: sarebbe un grande abbaglio anacronistico interpretare così quelle righe.
Per quanto il contesto conservatosi sia molto limitato, è abbastanza evidente che siamo di fronte al ben riuscito esercizio sofistico consistente nel mettere in crisi le certezze consolidate della città che si reputa democratica: e la leva per scuotere quelle certezze è pur sempre la scoperta dell’alterità tra legge e natura.
Un argomento spiazzante come quello dell’identità fisica (“naturale”) degli uomini può diventare distruttivo rispetto ai privilegi del demo (al potere in nome dell’eguaglianza: eguaglianza zeppa in una città piena di schiavi) ed è anche un’eccellente premessa per avvalorare altre forme politiche di gerarchia, come quelle appunto – fondate sulla competenza – che gli oligarchi pensanti e agguerriti rivendicano e propugnano.
E tenteranno di realizzare per ben due volte sul finire del quinto secolo: nel 411 sotto la leadership di Antifonte e nel 404 sotto la guida di Crizia.
Pag. 96
La riflessione sulle varie possibili forme di ‘giusta’ gerarchia politica, sui criteri di competenza che dovrebbero essere alla base di una sana gerarchia, sulle forme non ‘aritmetiche’ ma ‘geometriche’ di giustizia (ison, che vuol dire anche, al tempo stesso, giustizia e uguaglianza) bene si concilia con lo smantellamento dell’abisso che proprio la democrazia ateniese – a partire da Solone – ha frapposto tra il libero e lo schiavo.
Il potere di tutti purché di condizione libera è il bersaglio: perché quei tutti non sono selezionati affatto col criterio della competenza e si godono il bene derivante dallo status di cittadino pleno iure per la sola ragione di trovarsi dalla parte giusta (di non essere cioè piombati nel campo di coloro, gli schiavi, che la città democratica relega nel campo di non uomini).
Ecco come l’apparentemente semplicistico brano della Verità di Antifonte, lungi dall’essere un “Manifesto” ante litteram, si annoda bene alle premesse politiche e filosofiche di coloro che della città democratica additano il difetto alla radice e che non accettano il compromesso col “popolo sovrano” che consente ai maggiorenti di “guidare” ed “essere guidati” dalla massa incompetenze (per usare l’immagine cara a Tucidide nel ritratto di Pericle).
Pag. 97
Il frammento più lungo proviene dal Sisifo, dramma satiresco che, secondo l’ipotesi formulata da Wilamowitz, concludeva una tetralogia i cui primi tre drammi erano Tennes, Radamanto e Piritoo.
Del Piritoo merita attenzione almeno un frammento (22 Diels-Kranz), in cui un personaggio demolisce senza remore la figura del politico professionale (rhetor) dominatore delle assemblee: “un carattere nobile – così si esprime questo personaggio – è cosa più sicura della legge: giacché la legge un qualunque politico te la fa a pezzi e te la sconvolge in tutte le direzioni con le sue ciarle, ma il carattere non lo potrà mai abbattere”.
Pag. 99
Euripide non può essere poso in diretto rapporto con le convulsioni politiche della città, ma la sua vicenda personale – nei limiti in cui ci è nota – conferma quella vicinanza agli ambienti da cui quelle convulsioni si sprigionarono.
I dati che possiamo assumere come certi e particolarmente indicativi sono due: uno negativo e uno positivo.
Diversamente da Sofocle, impegnato a farsi eleggere stratego e a ricoprire cariche di grande peso (strategia, ellenotamia), Euripide si è rigorosamente astenuto da qualunque attività politica.
Come nel caso di Antifonte, è importante ciò che non ha fatto.
Il gesto che alla fine compie, andarsene via da Atene dopo il 408, è almeno altrettanto significativo della sistematica defezione dalla vita pubblica: se ne va quando viene restaurata, col rientro di Trasilio e della flotta di Samo e con la fine del regime ‘moderato’ (terameniano) dei ‘Cinquemila’, la democrazia.
Se a questo si aggiunge il buon rapporto con Crizia e il fatto di venir bersagliato sistematicamente, non meno di Socrate, dalla commedia – buon indicatore delle pulsioni dell’”ateniese medio” – il ritratto si chiarisce.
E si comprende tanto l’ostinazione sua nel porre in discussione i pilastri etico-politico-sociali della città democratica, quanto l’insuccesso sistematico di fronte al pubblico.
Non è casuale che l’ultima delle sue cinque vittorie, conseguita postuma, sia stata ottenuta nella spettrale Atene governata dai Trenta del 404/3.
Pag. 101
Non ci soffermeremo dunque sulla critica euripidea ai pilastri etici e sociali (famiglia, schiavitù, religione) su cui si fonda la città, ma guarderemo con una certa attenzione ad un caso concreto di critica politica: ad una discussione sul fondamento stesso della democrazia ateniese (e della democrazia in generale) che Euripide introduce nel bel mezzo di una tragedia, le Supplici (databili intorno al 424 a. C.), costruita ancora una volta intorno ad un mito ben noto al pubblico, quello della saga tebana e del destino dei sette assalitori di Tebe col relativo corollario del fratricidio.
Pag. 105
Cap. 3. Pericle princeps
Il contagio pestilenziale fu talmente sconvolgente per la città che lo storico cha ha raccontato quelle vicende, Tucidide, ha ritenuto di dedicare pagine alla descrizione della pestilenza e dei sintomi del contagio, “perché, se un domani ritornerà, si sappia come si presenta questo malanno”; e descrive la città in preda alla devastazione morale e materiale: cumuli di cadaveri bruciati per le strade, degrado morale, crollo dei freni che regolano la convivenza.
Pag. 113
Uno dei creatori della scienza politica, Thomas Hobbes, il quale a lungo non scrisse, e quando cominciò a scrivere tradusse Tucidide in inglese, premettendovi una mirabile introduzione, osserva a questo proposito che Tucidide ebbe una visione politica profondamente monarchica; infatti i due personaggi positivi della sua storia sono Pisistrato – il cosiddetto tiranno – e Pericle, il monarca.
Questa immagine della “democrazia solo a parole, ma di fatto governo del principe”, ha avuto una vitalità lunghissima.
Si potrebbe dire che l’idea stessa di princeps nella realtà politica della Roma tardorepubblicana prende le mosse da Pericle.
Il nome che è giusto fare è quello di Cicerone, il quale – teorico della politica, critico della decadenza della repubblica romana, quattro secoli dopo Pericle – sogna il princeps: ha l’idea che dalla difficoltà strutturale della repubblica si uscirà attraverso un princeps, e lo delinea nel De Republica, a giudicare dai frammenti che abbiamo, esattamente con le parole con cui Tucidide descrive il potere di Pericle: “Pericles ille, et auctoritate et eloquentia et consilio, princeps civitatis suae”.
Pag. 115
Nel Gorgia, è Socrate che parla, è lui che descrive i grandi corruttori della politica.
A suo giudizio, nella storia ateniese, sono quattro: Milziade, Temistocle, Pericle e Cimone.
Platone è spietato, come sempre, nella sua critica radicale del sistema politico ateniese.
I personaggi che qui condanna in blocco erano stati anche tra loro rivali, eppure li condanna tutti in quanto corruttori del popolo.
Perché fecero quello che Tucidide nega che Pericle abbia fatto: parlare pros hedonèn, “per far piacere” al popolo.
Rimprovera a Pericle proprio l’oratoria demagogica, l’assecondare l’assemblea e per questo, dice il Socrate del Gorgia, “ha reso gli ateniesi peggiori di quello che erano”.
Non soltanto lo condanna per questa oratoria demagogica, per questo assecondare il popolo, ma anche perché per primo introdusse un salario per i pubblici uffici.
Il salario per ricoprire una carica, che è l’architrave del meccanismo democratico ateniese.
Pag. 116
L’ordinamento ateniese, come ogni democrazia antica, ha nell’assemblea di tutti il fondamento.
Ma cos’è propriamente l’assemblea di tutti?
Quando Erodoto raccontò che alla morte di Cambise qualcuno aveva prospettato di instaurare la democrazia in Persia, “alcuni greci” non gli credettero.
Dire, per esempio ad Atene, che nell’Impero persiano, immensa realtà geografica, qualcuno volesse instaurare la democrazia significava far immaginare una assemblea di tutti in un grande Stato territoriale: qualcosa di impossibile.
Ma anche ad Atene l’assemblea di tutti è un’idea-forza.
Quando, molti anni dopo, gli oligarchi abbatteranno il sistema politico ateniese e abrogheranno il salario per i pubblici uffici, dichiareranno – come ben sappiamo – che in fondo, anche in regime assembleare, al massimo cinquemila persone andavano all’assemblea.
Atene a metà del 5. secolo ha trentamila cittadini maschi adulti in età militare.
La realtà concreta della democrazia assembleare è una realtà mobile, nella quale il corpo civico attivo può cambiare, come ora vedremo, in ragione dei rapporti di forza.
Pag. 116
Il tribunale è il ganglio intorno a cui si svolge la lotta di classe.
Spostare i poteri dell’Areopago in tribunali popolari significava spostare il peso decisivo su un altro ceto.
Questa è la riforma del 462.
Ed essa avviene perché all’assemblea c’erano altri.
Quattromila opliti erano in Messenia a combattere agli ordini di Cimone, e Efialte e Pericle realizzano con il sostegno di un’altra massa cittadina una riforma epocale.
Per maggiore chiarezza azzardiamo un paragone.
Si tratta di una realtà molto simile – per certi versi – a quella dell’Atene della democrazia diretta: la Parigi dell’anno 2. della Repubblica, la Parigi delle Sezioni.
Nelle Sezioni ci sono i sectionnaires, cioè i frequentatori abituali, i sanculotti.
Ammazzato Robespierre, i sanculotti se ne vanno dalle Sezioni e arrivano i borghesi.
Le Sezioni continuano a funzionare, quindi formalmente il meccanismo è lo stesso; però è come se nelle vene scorresse un sangue diverso.
E’ la stessa cosa che succede nel 462: assenti gli opliti, decidono i teti, i nullatenenti.
Fra Salamina e la terza guerra in Messenia, Atene è diventata una grande potenza marittima, la cui forza è nelle navi; quindi il soggetto sociale decisivo è diventato quello legato al potere navale, e Pericle deve fare i conti con i teti.
Pag. 116
“La storia non deve stancarsi di ripetere che in essa vige un criterio di misura del tutto diverso dalla moralità e dalla virtù privata” scriveva Droysen (1808-1884) nel 1838.
Cap. 4. Una critica non banale della democrazia
Scrive Aristotele che la svolta nel sistema politico ateniese del secolo precedente è rappresentata dal dopo Pericle, dall’affacciarsi alla direzione dello Stato di uomini come Cleone e Cleofonte.
Aristotele rende anche ‘visivamente’ questa volta, quando rileva il mutamento di tono, di stile, dovuto all’emergere dei nuovi capi popolari: il deterioramento infatti si verifica – per lui – appunto sul versante democratico.
Fino a Pericle, anche i capi popolari sono “onorati” (eudokimountes): dopo, emerge un Cleone, cioè colui che più d’ogni altro ha contribuito a corrompere il demo, colui che per primo “si mise ad urlare alla tribuna, a vomitare ingiurie, a parlare scoprendosi in modo scomposto”.
In questa raffigurazione sprezzante e caricaturale – che del resto nella tradizione su Cleone è quasi stereotipa – Aristotele focalizza emblematicamente il segno esterno della svolta prodottasi.
Alla politica dei signori era subentrata la politica dei popolani.
Così, quando, subito dopo, nomina Cleofonte, il capopopolo degli ultimi anni della guerra peloponnesiaca, lo chiama sprezzantemente “il fabbricante di lire”.
Pag. 130
E siamo così, per merito di questa apologia di Alcibiade, ancora una volta dinanzi ad una vera e propria divaricazione.
Alcibiade esprime la propria repugnanza per la demokratia, per questa “notoria pazzia”, con altrettanta durezza che il “vecchio oligarca” ma – all’opposto di lui ( o di un Frinico, o di un Antifonte) – è convinto che proprio la guerra e l’incombente minaccia militare del nemico abbiano reso impossibile qualunque tentativo di sovvertire questa “dittatura del demo”.
Mentre gli oligarchi promotori del colpo di Stato del 411 conteranno apertamente sull’aiuto spartano, mentre l’autore di questo opuscolo prospetta come unica seria ipotesi di salvezza il classico rimedio di “aprire le porte” e far entrare i nemici, per Alcibiade è veramente pericleo, poiché la distinzione di fondo è per lui, buon alcmeonide, tra l’ordine tradizionale (demo come opposto di tirannide) che ha reso Atene grandissima e liberissima e la demokratia, cioè il predominio incontrollato del demo.
Il primo va difeso, ed è un valore durevole, il secondo è transitorio ed è immodificabile finché c’è guerra.
Pericleo è, anche, Alcibiade, nella consapevolezza di essersi trovato spesso contro il demo ed i suoi ispiratori, così come Pericle è stato anche, temporaneamente, sconfitto, quando il demo gli si è posto apertamente contro.
E’ soprattutto con la formula “eravamo alla guida della comunità nel suo insieme (tou Xympantos)” che Tucidide rende chiaro il filo che congiunge Pericle ad Alcibiade come ideatori di una forte leadership che si pretende, super partes, guida di “tutta la comunità” (dalla Xympasa polis come si esprime Tucidide nel bilancio postumo su Pericle).
Pag. 149-150
Cap. 5. Demokratia come violenza
Demokratia non nasce dunque come parola della convenienza politica, ma come parola di rottura, esprime la prevalenza di una parte più che la partecipazione paritetica di tutti indistintamente alla vita della città (che è espressa piuttosto da isonomia).
Addirittura la democrazia nasce, secondo Platone, con un atto di violenza: “quando vincono i poveri, e uccidono alcuni dei ricchi, altri li scacciano, e ai rimanenti concedono di compartecipare alla pari alla vita politica e alle cariche, e per lo più in essa le cariche vengono affidate per sorteggio”; e prosegue osservando che questa instaurazione violenta si realizza o senz’altro con le armi ovvero per una spontanea autoesclusione del partito avverso “che si ritira in preda al terrore”.
Demokratia non racchiude in sé neanche l’implicita legittimazione derivante dal concetto di “maggioranza”; concetto, questo, ben più presente in plethos che in demos.
Non a caso Otanes, nel dibattito costituzionale che si sarebbe svolto secondo Erodoto, alla corte persiana nel corso della crisi successiva alla morte di Cambise, dice che il plethos archon, cioè appunto “il governo della maggioranza” ha il nome più bello, isonomia.
Su questo punto Aristotele è molto chiaro ed esplicito:
“Non si deve definire la democrazia alla maniera che sogliono oggi alcuni, come il predominio dei più numerosi, né l’oligarchia come il regime in cui pochi sono i padroni dello Stato.
Se infatti, per fare un esempio, i cittadini fossero in tutto 1300, e di costoro 100 fossero ricchi e non concedessero l’accesso alle cariche restanti 30 non ricchi, ma peraltro liberi e per il resto uguali, nessuno direbbe che quello è un regime democratico.
Analogamente, se i poveri fossero pochi ma egemoni rispetto ai ricchi, più numerosi, nessuno definirebbe oligarchia un tale regime, sol perché tutti gli altri, che in questo caso sarebbero i ricchi, si troverebbero esclusi dalla cariche pubbliche.”
Pag. 152-53
Dunque demokratia vale essenzialmente dominio di un gruppo sociale – il demo -, non necessariamente della maggioranza; e demo sono “i poveri tra i cittadini”, secondo la definizione senofontea, o meglio, come precisa Aristotele, “agricoltori, artigiani, artigiani, marinai, manovali, commercianti”.
Pag. 154
Il Pericle tucidideo dunque pone l’accento sull’uguaglianza (to ison), intesa appunto – e il Menesseno lo rispecchia fedelmente – come antitetica rispetto al dominio di una sola parte.
Giacché to ison è, al tempo stesso, “ciò che è uguale” e “ciò che è giusto”.
Quello Che è potuto sembrare l’elogio pericleo, talora imputato addirittura allo stesso Tucidide, della “democrazia” ateniese è invece uno dei testi che maggiormente ‘prendono le distanze’ da una tale forma politica.
Nel famoso dialogo senofonteo tra il vecchio Pericle e il giovane Alcibiade intorno alla violenza e alla legge, la conclusione è che, quando la massa legifera prevalendo sui ricchi, quella è violenza, non è legge.
Pag. 155
Cap. 6. Egualitarismo antidemocratico
Ma l’evoluzione più interessante si produce, per influenza della sofistica e della sua scoperta del contrasto tra la natura e la legge, in un’ala oligarchica-radicale che si è anche resa responsabile, sul piano politico, dei più clamorosi tentativi di sovvertimento dell’ordine democratico.
Nella sua critica estrema ai privilegi del demo, più di un teorico oligarchico sembra assumere come punto di riferimento proprio quello che per un Teognide era il disvalore assoluto, cioè lo schiavo.
Lo schiavo, cioè la prova ‘vivente’ del fondamento genetico della disuguaglianza e delle differenze di casta (il figlio di una schiava sarà uno schiavo anch’esso).
Orbene un Antifonte, il temibile, lo scontroso, il “troppo bravo” Antifonte – come ce lo rappresenta Tucidide nell’appassionato ritratto – intacca proprio questa certezza.
Pag. 157
Sempre nell’Athenaion Politeia spicca la notazione, polemica, secondo cui ad Atene anche gli schiavi se la passano bene: ma per rilevare contestualmente che il demo non è esteriormente distinguibile dagli schiavi (1., 10).
Qui, in questa affermazione che ad Atene schiavi e demo nemmeno si distinguono, ci sono le premesse per un ulteriore passo: perché mai il demo, che è in tutto uguale agli schiavi, accentra nelle proprie mani la politeia?
Alle spalle c’è, evidentemente, il riconoscimento dell’uguaglianza “di natura” tra gli uomini, che è la dirompente scoperta della sofistica.
Ma questa scoperta – che finiva col mettere in discussione proprio i privilegi del demo - si è tradotta, politicamente, in esperimenti ultra oligarchici.
Ha costituito ad esempio, nel caso dei Trenta, la premessa non per esperimenti ‘utopistici’, ma al contrario per il tentativo di abbassare il demo al livello degli schiavi, espropriandolo dello ‘spazio politico’.
Coi Trenta sembra quasi di veder tradotta in esperimento concreto l’idealità di un sofista “egualitario” coem Falea di Calcedone, teorico, a cavallo tra quinto e quarto secolo, di un rigido livellamento delle proprietà e dei patrimoni, e al tempo stesso propugnatore della riduzione di tutti i lavoratori manuali (artigiani etc.) al livello di “schiavi pubblici” (demosioi) – un’anticipazione, per certi aspetti, del cosiddetto “comunismo platonico”.
Pag. 159
Certo, è proprio sul tema del rapporto con gli schiavi che la democrazia viene attaccata dai suoi avversari.
Si può dire anzi che quello della maggior licenza degli schiavi in regime democratico è quasi un topos.
Secondo Platone, l’estremo segno degenerativo, nella città retta dal demo, si ha “quando gli schiavi e le schiave sono liberi tra uomini e donne”.
E Teramene, quando vuol definire gli ideali della democrazia radicale, dice: “io ho sempre combattuto contro coloro che apprezzano la democrazia solo quando a comandare sono gli schiavi e i poverissimi che venderebbero la città come per una dracma”.
Pag. 160
La democrazia radicale, dunque, che è la principale beneficiaria della guerra, è anche responsabile di questa condizione più ‘libera’ e di benessere assicurata agli schiavi.
E’, per così dire, un sistema schiavistico imperfetto.
Quando, nel secolo successivo, il demo avrà perso l’egemonia politica, e sarà economicamente immiserito, e la pressione servile si sarà fatta più pesante e i ricchi non ce la faranno più da soli a difendersi, allora l’impegno ad impedire “esili, confische di beni, suddivisioni di terre, remissioni di debiti, liberazione di schiavi a fini sediziosi” sarà sancita, con la massima evidenza, in un trattato internazionale imposto, dopo Cheronea, da Filippo, disinvolto protettore delle fazioni oligarchiche nelle città greche”.
Pag. 163
Parte seconda: Il buco nero: Melo
Cap. 7. Il terribile dialogo
Cap. 8. La vittima esemplare
E’ stata una vittoria della propaganda sulla verità ad opera del maggiore storico ateniese esaltatore alquanto autolatrico del “valore perenne” della “faticosa ricerca della verità”: in un certo senso un vero capolavoro.
Pag. 173
Intorno alla vicenda di Melo vi fu di certo un moto di opinione per lo meno in ambienti presso i quali l’impero era oggetto di critica.
Ripristinata la corretta informazione sui presupposti della vicenda (Melo ha defezionato e col tempo è passata a sostenere occultamente lo sforzo bellico spartano), resta il fatto macroscopico della decisione ateniese di regolare i conti con Melo proprio nel 416, cioè ben cinque anni dopo la stipula della pace con Sparta.
E’ in questa punizione ritardata il motivo della scandalo.
Era usuale (lo attesta Isocrate, Panegirico, 100)rinfacciare ad Atene la feroce repressione di Scione e di Melo: quei due episodi venivano citati insieme (conferma tra l’altro dell’affinità delle due vicende), ma Scione aveva defezionato subito dopo Amfipoli, dunque in piena guerra (424/3) ed era stata esemplarmente punita da Cleone appena possibile (422/1).
Invece per Melo si attinsero anni prima di intervenire.
L’intervento si sviluppò in tre fasi distinte: a) sbarco e tentativo di trattativa; b) fallimento della trattativa e assedio; c) resa e punizione durissima dei Melii, voluta da Alcibiade (circostanza, quest’ultima, taciuta da Tucidide).
pag. 174
Cap. 9. Euripide a Melo
Nell’estate del 416, quando l’invio di una flotta contro Melo era stato appena deciso o la flotta era al più appena sbarcata nell’isola, Euripide chiese il coro per una tetralogia dedicata al ciclo troiano: Alessandro, Palamede, Troiane e il dramma satiresco Sisifo.
Essa fu rappresentata alle Dionisie del 415 (marzo), quando ormai Melo era stata conquistata, una cleruchia ateniese insediata, gli abitanti sterminati, le donne rese schiave.
Sino a quel momento la grande spedizione contro Siracusa non era stata ancora portata in discussione dinanzi all’assemblea.
Che dunque la tetralogia culminante nel dramma (le Troiane) consacrato al duro destino delle prigioniere troiane sia stata concepita sull’onda della campagna contro Melo – come si è talvolta cercato di dimostrare – è ipotesi più che legittima.
Problematica può apparire la connessione da taluno istituita tra le Troiane ed il sorgere in Atene di una psicosi di massa favorevole alla spedizione contro Siracusa: Tucidide data, peraltro assai sommariamente, tale “volontà diffusa” nell’inverno 416%5 (6., 1, 1,), quando cioè la tetralogia veniva ormai rappresentata.
Pag. 177
L’attacco contro l’isola di Melo fu sferrato in tempo di pace, mentre cioè era in vigore la pace stipulata nel 421 che si suole definire “pace di Nicia” in quanto da lui fortemente voluta e sottoscritta.
Questo elemento resta spesso in ombra, nella considerazione moderna di quella vicenda, grazie all’impalcatura stessa del racconto tucidideo che enumera come “anni di guerra” anche gli anni di pace.
Si aggiunga la tendenza dell’intero racconto tucidideo a ridimensionare quella pace come “tregua infida” e si aggiunga poi che l’impostazione tucididea, , del tutto originale, secondo cui dal 431 al 404 non ci fu che un’unica guerra ha prevalso, per cui l’idea di una ininterrotta guerra ventisettennale è divenuta senso comune.
Il che ha portato a rubricare la vicenda di Melo come un episodio di guerra.
Ciò ha sminuito enormemente la gravità dell’iniziativa ateniese, che invece va rimessa in luce e che trova conferma anche nell’accanito e prolungato dibattito sulle responsabilità ateniesi in quella vicenda che riappare carsicamente nella riflessione politica ateniese (nei limiti in cui ci è nota) fino alla vigilia di Cheronea, alla fine quasi del secolo seguente.
La visione unitaria della guerra spartano-ateniese considerata come un unico conflitto, ancorché legittima e audace al tempo stesso, non fu fatta propria né dai contemporanei né nel secolo successivo dai pensatori e dagli oratori politici ateniesi.
Questo è stato più volte osservato, ma non è superfluo ripeterlo qui.
Che i contemporanei (o almeno una parte di essi) si sentissero, dopo il 421, ritornati ad una condizione di pace ed ai vantaggi che ne derivano lo si ricava per esempio dalle argomentazioni, tutt’altro che inefficaci sul pubblico dell’assemblea, svolte da Nicia nel dibattito assembleare intorno alla proposta messa in moto da Alcibiade di intervenire in grande stile in Sicilia.
Il rifiorire di Atene “inconseguenza della pace di Nicia” è descritto con toni molto netti e con dovizia di dettagli da Andocide, quando rievoca quegli anni nel suo discorso Sulla pace con Sparta (8) del 392/391.
Ed un acuto lettore rinascimentale di questa emblematica vicenda – il Machiavelli – aveva ricavato, non a torto, la conclusione che Atene avesse vinto la guerra decennale (431-421).
Vi era dunque, sul momento, e vi fu a lungo dopo, un’altra visione della storia della guerra che portava a collocare l’intervento contro Melo in una luce – se possibile – ancor più negativa: e, se per lo meno per i contemporanei, più veridica.
Pag. 180-81
Sparta ovviamente non intervenne, e sarebbe stato del resto ben singolare in un momento in cui, nonostante tutto, Sparta e Atene erano pur sempre legate dal trattato di alleanza stipulato nel 421 subito dopo la stipula della pace.
Per il Melii fu micidiale quella scelta della grande potenza in cui avevano confidato.
Ma nel 404 Lisandro, su ordine degli efori, riportò i Melii superstiti (ben pochi ovviamente) nella loro isola, forse ancora ingombra dai 500 cleruchi ateniesi installatisi dopo il massacro.
E così Sparta, luogo privilegiato dell’eunomia, poté far quadrare ancora una volta i conti della potenza e della virtù.
Pag. 186
Cap. 10. Isocrate demolisce la costruzione polemica tucididea sulla vicenda di Melo
Werner Jaeger seppe cogliere l’intreccio profondo che lega la colossale messinscena tucididea sulla vicenda di Melo.
E scrisse, in un veloce, intelligente appunto nascosto in un angolo di un libro non riuscitissimo come il Demosthenes, che Senofonte ha perseguito “una unità intrinseca (Einheit der inneren Haltung)” rispetto a Tucidide.
E’ più ragionevole pensare che, semplicemente, si tratta di Tucidide in un caso come nell’altro.
Oltre tutto, la storia editoriale del lascito tucidideo si comprende ancora meglio se si considera la vicinanza politica tra Tucidide e Senofonte, cementata, potremmo dire, dall’esperienza di entrambi nelle due oligarchie.
Pag. 189
Intermezzo
Cap. 11. Effetti imprevisti del “mal di Sicilia” (415 a. C.): ciò che Tucidide vide
Fu una smania di salpare che Tucidide con parola che non adopera mai altrove definisce “eros” o anche “desiderio smodato”: “Volevano andare in Sicilia per sottometterla.
In realtà i più non conoscevano neanche le dimensioni dell’isola, quali popoli la abitassero, quanti fossero i barbari e quanti i greci; non capivano di imbarcarsi in una guerra grande quanto quella che avevano combattuto contro Sparta e i suoi alleati”.
E qui, con orgogliosa polemica contro le scelte impulsive dei suoi concittadini, traccia da esperto geografo et etnografo un profilo della Sicilia e del suo popolamento.
Dopo di che commenta: “E’ contro un’isola di teli dimensioni che gli ateniesi volevano muoversi: il loro vero desiderio era di conquistarla tutta quanta, dicevano però di coler proteggere le popolazioni di stirpe affine ed i loro alleati recenti”.
Ma c’era chi concepiva progetti anche più ambiziosi: Alcibiade, affacciatosi ancora giovanissimo alla politica e illustratosi in un infelice esordio diplomatico e militare nei due anni precedenti, al di là della Sicilia pensava addirittura a Cartagine: anzi la conquista della Sicilia era per lui “la premessa per la conquista di Cartagine”.
Pag. 194
Parte terza. Come perdere la guerra avendola vinta
Antefatto
Diversamente dai suoi contemporanei, nonché dagli storici e politici del secolo successivo, Tucidide – lo abbiamo già ricordato – ha intuito la sostanziale unità del conflitto apertosi nella primavera del 431 a. C. con l’ultimatum spartano e terminato con la capitolazione di Atene nell’aprile del 404.
Tale visione unitaria trova un calzante parallelo nella valutazione delle due guerre mondiali sviluppatesi nella prima metà del Novecento come fasi di un unico conflitto.
In entrambi i casi si tratta di due periodi bellici prolungati, nell’intervallo tra i quali si producono conflitti minori e tensioni in altre aree, sicché la pace stessa che conclude il primo dei due (la pace di Nicia nel primo caso, la pace di Versailles nel secondo) viene percepita come qualcosa di provvisorio.
Va però osservato che la coscienza di tale unità si forma, necessariamente, a posteriori.
E’ lo sviluppo degli avvenimenti che dà via via maggior forza all’idea che il primo conflitto si sia solo apparentemente concluso e sia inevitabilmente riaperto per proseguire finché uno dei due grandi soggetti in lotta soccomba definitivamente.
Fermo restando, comunque, che la persuasione stessa che si sia alla fine giunti ad un epilogo veramente conclusivo viene non di rado messa in discussione dall’ulteriore sviluppo degli avvenimenti: a riprova del fatto che qualunque periodizzazione storica è provvisoria.
Non a caso Teopompo ha proseguito l’opera di Tucidide continuando fino al 394 a. C., cioè fino alla rinascita delle mura di Atene abbattute nella capitolazione del 404.
Nel caso della riflessione storico-politica di Tucidide sulla grande guerra di cui fu testimone, vediamo affiorare man mano nella sua opera la scoperta dell’unità dell’intero conflitto.
Per parte loro, d’altro canto, Lisia, Platone, Eforo continuarono a ragionare in termini di tre guerre distinte: guerra archidamica (431-421 a. C.), conclusa da una pace molto impegnativa quale la cosiddetta pace di Nicia, guerra siciliana (415-413 a. C.), guerra deceleica (413-404 a. C.).
Era ben presente a questi interpreti della vicenda ateniese che la pace di Nicia aveva segnato un punto fermo e che, come Nicia aveva temuto, fu proprio l’attacco di Atene contro Siracusa nel 415 a provocare la riapertura del conflitto tra Sparta ed Atene, principali firmatari della pace di Nicia.
e poiché l’attacco ateniese contro Siracusa non era una mossa inevitabile, ne discende che la riapertura catastrofica per Atene del conflitto era soltanto una, ma non l’unica delle possibilità sul tappeto.
La stessa grande discussione in assemblea popolare tra Nicia che sconsiglia l’impresa siciliana e Alcibiade che la caldeggia cavalcando un’ondata di opinione pubblica infiammatasi per la presunta facile conquista dell’Occidente, significa per l’appunto che due strade si aprivano e che la svolta bellicista non era una scelta inevitabile.
Quando dunque Tucidide dà tanto rilievo al fatto che due strade si aprivano e fu imboccata quella sbagliata, con ciò stesso dimostra di non aver ancora maturato la visione in certo senso deterministica di un conflitto unitario, destinato inevitabilmente a riaprirsi e a concludersi con l’annullamento di una delle due potenze in lotta.
Una tale visione egli l’ha maturata via via, quando ha potuto constatare che Sparta e Corinto si inserivano nella guerra tra Atene e Siracusa e riaprivano il conflitto in Grecia denunciando la pace di Nicia.
La conquistata visione unitaria ha prodotto integrazioni importanti nel primo libro dell’opera sua, quali il rapido profilo del cinquantennio tra le guerre persiane e lo scoppio del conflitto con Sparta, nonché quel memorabile breve commento che egli colloca al termine del congresso di Sparta, dove dichiara che gli spartani accedettero alle sollecitazioni corinzie in pro di una risposta militare alla crescente egemonia ateniese “non perché persuasi dai corinzi e dagli altri alleati, ma perché ormai temevano l’accrescersi costante della potenza ateniese e vedevano che la gran parte della Grecia era soggetta ad Atene”.
Scoperta dell’unità dell’intero conflitto, intuizione della “causa verissima” (allarme spartano di fronte alla crescente potenza imperiale ateniese), necessità di tracciare un rapido profilo della genesi e crescita dell’impero ateniese, sono dunque tutti fenomeni strettamente intrecciati tra loro e costituiscono la traccia sotterranea per dipanare, perlomeno a grandi linee, la stratigrafia compositiva del racconto tucidideo.
Ma gli effetti di tale scoperta, che reinterpretava originalmente un’intera fase storica, ha avuto come conseguenza – nella mente dello storico – un processo di svalutazione del rilievo di alcune tappe del conflitto inizialmente da lui stesso considerate di grande importanza: per esempio, gli incidenti (Corcira, Potidea, l’embargo contro Megara) che precedettero di qualche anno lo scoppio del conflitto, e che inizialmente erano parsi a Tucidide cause talmente rilevanti da richiedere un’esposizione analitica che occupa gran parte del primo libro.
Analogamente si spiega il racconto minuziosamente analitico della campagna siciliana, la quale dovette dapprima essere concepita come la narrazione di un altro conflitto, con un suo proprio proemio etno-geografico, e divenne poi parte di un racconto molto ampio, i cui anni di guerra vengono immessi nell’unica progressiva numerazione dei ventisette anni.
E’ di per sé evidente che questa modifica in corso d’opera della visione generale del conflitto, nel giudizio tucidideo, ha determinato scompensi narrativi: che parvero sconvenienti ad un critico puntiglioso ma non profondo come Dionigi d’Alicarnasso.
Orbene, nel quadro dalla acquisita visione unitaria del conflitto, è evidente che la pace di Nicia finisce con l’apparire ed essere presentata come poco più che una tregua.
Ma tale non fu la percezione dei contemporanei e forse fino ad un certo momento dello stesso Tucidide, come è chiaro dalle stesse parole che egli fa pronunciare a Nicia all’inizio del libro 6., là dove Nicia descrive la ripresa economica appena avviata grazie alla pace dopo il decennio di invasioni spartane dell’Attica.
Questa svalutazione del significato della pace di Nicia comporta che resti in ombra, nel racconto tucidideo, il più macroscopico dei risultati della pace: il riconoscimento finalmente formalizzato dell’impero ateniese da parte spartana e l’accettazione della sua consistenza ‘territoriale’.
Se solo si considera che la nascita stessa dell’alleanza stretta intorno ad Atene aveva rappresentato una rottura di fatto dell’alleanza panellenica capeggiata da Sparta, sorta con l’invasione di Serse (480 a. C.), ben si riesce a comprendere la portata epocale della presa d’atto da parte spartana dell’ufficiale esistenza e legittimità dell’impero ateniese.
Tale presa d’atto è affidata al testo della pace di Nicia, che Tucidide stesso ci ha conservato.
Chi dunque pensi, come il Machiavelli, che Atene aveva “vinto la guerra” non è fuori strada.
La frequentazione dei testi greci da parte del Machiavelli fu indiretta ma sempre all’altezza della sua penetrante capacità di leggere politicamente il passato.
Nel libro terzo dei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio il Machiavelli tocca quasi per caso questa materia e approda ancora una volta ad una delle sue drastiche formulazioni geniali.
Prende spunto da un problema squisitamente politico e cioè il maggior peso che le élites acquistano in caso di guerra.
A suffragio di questa sua tesi porta il caso di Nica di fronte alla campagna siciliana e inserisce, cosa piuttosto insolita per lui, un ampio riferimento al racconto tucidideo.
Ed è qui che lascia cadere quasi per incidens una dichiarazione che al lettore moderno appare quasi stravagante e che invece è profondamente vera, che cioè Atene avesse vinto la guerra: ovviamente la guerra decennale, conclusasi con la pace di Nicia, la cui portata politica e diplomatica gli è perfettamente chiara:
“Egli fu sempre, e sempre sarà, che gli uomini grandi e rari in una repubblica, ne’ tempi pacifichi, sono negletti; perché, per la invidia che si ha tirato dietro la riputazione che la virtù d’essi ha dato loro, si truova in tali tempi assai cittadini che vogliono, non che essere loro equali, ma essere loro superiori.
E di questo ne è uno luogo buono in Tucidide, istorico greco; il quale mostra come, sendo la repubblica ateniese rimasa superiore in la guerra peloponnesiaca, ed avendo frenato l’orgoglio degli spartani, e quasi sottomessa tutta l’altra Grecia, salse in tanta riputazione che la disegnò di occupare la Sicilia.
Venne questa impresa in disputa in Atene.
Alcibiade e qualche altro cittadino consigliavano che la si facesse, come quelli che, pensando poco al bene pubblico, pensavono all’onore loro, disegnando essere capi di tale impresa.
Ma Nicia, che era il primo intra i reputati di Atene, la dissuadeva: e la maggiore ragione che, nel concionare al popolo, perché gli fusse prestato fede, adducesse, fu questa: , che consigliando esso che non si facesse questa guerra, e’ consigliava cosa che non faceva per lui; perché, stando Atene in pace, sapeva come vi era infiniti cittadini che gli volevano andare innanzi; ma, facendosi guerra, sapeva che nessuno cittadino gli sarebbe superiore o equale (cap. 16)”.
Pag. 206-210
Cap. 12. Scandali e oscure trame (415 a. C.) con una silloge di documenti
Cap. 13. Lotta politica nella grande potenza d’Occidente: Siracusa, 415 a. C.
Ne consegue – in Magna Grecia e in Sicilia – una tradizione di democrazia totalitaria che sfocia normalmente in ‘tirannide’, cioè in un forte potere personale repressivo verso i ceti alti, e, necessariamente, sia pure in diverse forme, verso l’intera società.
Dal punto di vista dell’immagine consolidata dalla storiografia greca superstite e successiva, questo tipo di democrazia totalitaria è rimasto perdente.
La competizione, in Magna Grecia e in Sicilia, tra democrazia e tirannide spiega, o aiuta a capire, perché la ‘tirannide’ occidentale duri così a lungo.
Essa prolunga la sua esistenza nel 5. e nel 4. secolo a. C. (e in certi casi fono alla conquista romana) appunto perché è la forma che li assume la democrazia.
Al contrario in Grecia la ‘tirannide’ per una lunga fase scompare.
Lo scenario ateniese è del tutto diverso.
Qui la democrazia si compenetra con l’individualismo dei ceti alti, assertori, come si sa, della isonomia e assai poco inclini, anzi in genere ostili, alla demokratia (“potere popolare”).
Il principio che informa la concezione aristocratica della eleutheria/isonomia, e che è largamente teorizzato nell’epitafio pericleo-tucidideo è: tutti, ricchi o meno, siano liberi di esprimere le rispettive potenzialità, ma vinca il migliore”.
Pag. 241
Cap. 14. Internazionalismo antico
Ma l’episodio ha rilievo anche per l’aspetto relativo all’automatismo delle alleanze: i signori, appena la città è sconfitta, rovesciano il demo grazie alla vittoria spartana contro la propria città.
Nel caso dei “signori” quell’automatismo ha funzionato senza scosse né incertezze.
Atene può scontrarsi, perseguendo la sua politica di potenza (che è il suo principale obiettivo), anche contro città che non siano rette da oligarchie.
Sparta non si è mai trovata, da quando si è sprigionato il conflitto con Atene per l’egemonia, ad appoggiare regimi popolari.
L’aiuto a Siracusa è dato in nome della comuen origine ‘dorica’, ma, ovviamente, ha la sua ragion d’essere nella politica di potenza.
Si può azzardare dunque una diagnosi di carattere generale: nel mondo greco, nell’età dei conflitti per l’egemonia, sono gli oligarchi i veri “internazionalisti”.
Pag. 245
Cap. 15. La guerra totale
Tra le guerre del 5. secolo a. C. la cosiddetta guerra peloponnesiaca fu l’unica che non si risolse con una o due battaglie (“con due battaglie navali e due terrestri” si era risolta la più grande delle guerre precedenti, la guerra contro Serse, coem notava Tucidide nell’ultimo capitolo del suo lungo proemio).
Ma questo fu chiaro dopo.
O meglio fu sempre più chiaro via via che la guerra venne assumendo un aspetto nuovo dal punto di vista militare: quello di uno stato di belligeranza che poteva durare anni, nonostante il verificarsi di scontri che in altri contesti sarebbero risultati immediatamente risolutivi.
Né la cattura a Sfacteria di tanti spartiati in un solo scontro, né la sconfitta ateniese a Delion, bastarono a porre termine al conflitto.
Conflitto che si sviluppa, negli anni della guerra decennale, e poi daccapo durante la “guerra deceleica” (413-404 a. C.), come un susseguirsi di scontri marginali e relativamente impegnativi che sfociano ad un certo momento in più impegnativi eventi militari, per attestarsi subito dopo in una conflittualità più limitata, e così via.
E’ come se i belligeranti si studiassero, magari impegnandosi in scontri di modesta entità, in vista del momento in cui imporre all’avversario lo scontro risolutivo nelle condizioni per lo più sfavorevoli.
Di qui l’andamento del conflitto, simile in questo alle guerre moderne ben più che alle guerre arcaiche, di cui i greci fino a quel momento avevano fatto esperienza (fatta eccezione, s’intende, per il lungo e remoto assedio di Troia.
Pag. 246
La definizione di “guerra totale” tenta di rispondere al quesito: perché in tutta la storia millenaria dei greci soltanto la “guerra peloponnesiaca” durò tanto a lungo.
Non ci riferiamo soltanto alla originale concezione tucididea di un unico conflitto ventisettennale, bensì anche ai due conflitti ‘parziali’, entrambi durati ben dieci anni, la guerra detta “decennale” (431-421) e la guerra detta “deceleica” (413-404).
Tucidide, il cui racconto è sapientemente selettivo, dietro l’apparenza di una quasi inscalfibile né ulteriormente dilatabile (ma apparente) totalità, ci guida nella comprensione di un andamento bellico nel quale lo “stato di guerra” perdura indipendentemente dalla frequenza con cui avvengono scontri terrestri e navali e indipendentemente dalla loro distruttività.
Non è che si combatta ininterrottamente, ma i due principali contendenti cercano costantemente dove e quando colpire.
Ciascuno punta ad infliggere colpi con le armi in cui si considera più forte e sul terreno che stima più favorevole.
Di qui la discontinuità dello scontro diretto pur nella continuità dello status di guerra e l’ampiezza crescente del teatro di operazioni.
E’ sintomatico, e aiuta a comprendere il fenomeno, il fatto che, già nel caso della guerra decennale, Atene tenti più volte di intervenire in Sicilia (nel 426 e poi nel 422), ben prima dell’intervento in grande stile del 415 che trasformerà definitivamente, e fino al momento della capitolazione di Atene, la guerra ‘peloponnesiaca’ in guerra mediterranea, da Siracusa al Bosforo alle isole dell’Egeo antistanti l’Asia.
Pag. 248-49
E soprattutto guerra civile andrebbe preso in altro senso rispetto a quello che Hanson mutua dall’esperienza della guerra di secessione americana.
Fu guerra civile, come s’è detto (cfr. paragrafo 2), perché erano in gioco al tempo stesso l’egemonia e i modelli politici: per la semplice e macroscopica ragione che l’egemonia che Atene era venuta acquisendo era coessenziale al suo sistema politico (la democrazia imperiale) e si fondava sull’esportazione/importazione di quel modello nelle città alleate/suddite.
E’ per questo che Lisandro, nel momento della vittoria finale, pretende anche e contestualmente il cambio di regime nella città finalmente sconfitta, anche se tale cambio non figurava formalmente tra le clausole della capitolazione.
Il fatto che le cose abbiano preso presto, già poco dopo la vittoria, un’altra piega nulla toglie alla lucidità dell’intuizione del vincitore.
Ma come non ricordare, a questo proposito, che anche per il secondo conflitto mondiale, nonostante quasi ogni scelta dei contendenti in lotta sia stata dettata dal calcolo realpolitico più che dalle opzioni ideologiche e di principio, fu comunque anche una gigantesca guerra civile?
Ecco perché l’analogia diagnostica più efficace, per comprendere l’interminabile conflitto 431-404, resta pur sempre quella del conflitto che occupò la prima metà del Novecento.
Ed ecco perché la sola definizione appropriata a connotarlo è quella di “guerra totale”.
Pag. 250
Parte quarta. La prima oligarchia: “Non era impresa da poco togliere la libertà al popolo ateniese”.
Cap. 16. Anatomia di un colpo di Stato: il 411
Da quando in Atene si era presa coscienza della catastrofe siciliana il clima politico era mutato.
Un primo segno erano stati i propositi di “buona amministrazione” su cui Tucidide posa un velo di ironia.
Sta di fatto che per i nemici della democrazia, per coloro che da sempre l’avevano avversata come il peggiore dei regimi, quella catastrofe era la prova di quanto rovinoso fosse un tal regime, un regime nel quale ”il primo capitato può prendere la parola” e la città può essere portata perciò alla rovina dalla avventata decisione di un giorno.
Oltre tutto la democrazia è un sistema disperante: “Il popolo può sempre addebitare la responsabilità delle decisioni a quell’unico che ha presentato la proposta o l’ha messa ai voti, e gli altri tirarsi indietro dicendo: io non ero presente!”.
E’ la stessa irresponsabilità politica denunciata da Tucidide quando ricorda l’indignazione della gente contro i politici che avevano caldeggiato la spedizione siciliana: “come se non l’avessero votata essi stessi!”.
Insomma parve giunto il momento della resa dei conti.
Il disastro era troppo grande, l’emozione e la paura troppo forti, e l’occasione quindi troppo favorevole perché i circoli oligarchici, l’opposizione occulta, i vecchi inaspriti e i giovani “dorati” dell’antidemocrazia non passassero all’azione.
La nomina dei dieci “anziani tutori” della politica cittadina – l’altro provvedimento sotto l’impressione della sconfitta – non era che un primo segno del nuovo clima che veniva maturando.
Un clima nel quale lentamente le parti si invertono.
Se nel predominio popolare e assembleare sono i signori, i “nemici del popolo” che per lo più tacciono, ora incomincia a verificarsi il contrario.
Ora gli oligarchi proclamano davanti all’assemblea un programma, che era la negazione del principio base della democrazia periclea del salario minimo per tutti: sostenevano che soltanto chi serviva in armi poteva ottenere un salario e che non più di cinquemila cittadini dovevano avere accesso alla politica.
In tempi normali nessuno avrebbe osato anche solo profferire queste ipotesi senza cadere sotto l’accusa pericolosa di “nemico del popolo”.
L’assemblea e il Consiglio continuavano a riunirsi, ma non decidevano se non quello che stabilivano i congiurati, “e ormai chi parlava nell’assemblea erano soltanto loro ed esercitavano la censura preventiva su qualunque intervento altrui”.
La crisi politica di Atene in questi mesi cruciali della primavera del 411 è tutta in questo mutamento: gli oligarchi hanno preso il potere servendosi né più né meno che degli strumenti propri del regime democratico.
Pag. 252-53
Piegarsi a riflettere su questi eventi, in sé effimeri, è per Tucidide come concepire e comporre un manuale di fenomenologia politica, i cui temi sono: come il popolo perde il potere, come il terrore bianco riesca a paralizzare la volontà popolare e renda innocua la “maggioranza” indotta addirittura a decretare la propria decapitazione politica, come gli oligarchi siano incapaci di tenere il potere quando l’hanno conquistato perché subito scoppia tra loro la rivalità e la spinta al dominio di uno solo, come al politica estera determini, in ultima analisi, quella interna, onde la perdita dell’Eubea porta alla rapida fine dell’oligarchia allo stesso modo che alla sconfitta in Sicilia aveva affossato la già turbata democrazia.
Pag. 254
Il regime oligarchico non sopravvisse a questa débâcle.
Appena giunte le notizie dall’Eubea si tenne, immediatamente, una prima assemblea in cui i capi dell’oligarchia, i cosiddetti “Quattrocento” furono deposti e tutti il potere passò ai “Cinquemila” (la cui lista peraltro non era stata mai fatta, e che solo ora fu definita); nei giorni successivi si tenne una serie di assemblee che portarono all’elezione di nomoteti e ad altre decisioni relative alla costituzioni (97,2).
Pag. 258
Cap. 17. Tucidide tra i “Quattrocento”.
Densità narrativa.
E’ questo l’elemento distintivo di quell’unicum che è la cronaca dei meno du quattro mesi del governo oligarchico del 411 che leggiamo nell’8. libro di Tucidide, e che ne occupa la metà.
Nessun episodio ha, nell’opera, un tale spazio.
Forse solo Sfacteria (oltre due mesi): e Tucidide probabilmente era lì e ha visto da vicino l’assedio.
Non basta dire: ‘s’informava’.
Nessuna informazione recuperata interrogando testimoni può produrre una narrazione praticamente quotidiana, in grado cioè di rispecchiare lo svolgimento quotidiano degli eventi.
Un raffronto obbligato e illuminante è costituito da Erodoto.
Egli narra fatti che certamente non ha visto (le guerre persiane) con una densità narrativa illusoria: la densità del suo racconto, anche per la seconda guerra persiana, è ben più lassa.
Avevo affrontato la questione del carattere apparentemente totale (senza ‘vuoti’) ma in realtà selettivo della narrazione storiografica in generale, e antica soprattutto, circa quarant’anni fa in Totalità e selezione nella storiografia classica (Laterza).
E resto del parere che quel criterio sia valido: la ‘densità narrativa’ come strumento che ci può orientare nel valutare la genesi di ciò che leggiamo nelle opere storiografiche degli antichi.
Punto di partenza resta l’intuizione di Eduard Schwartz nelle prime pagine del suo saggio sulle Elleniche senofontee.
Pag. 269
Cap. 18. Il principale responsabile
Se è vero sempre che “la storia vera è quella segreta”, come ebbe a dire felicemente Ronald Syme, più che mai lo è nel caso di una congiura; e, più in generale, dovunque l’azione politica sia svolta o promossa da società segrete.
Le ‘eterie’ ateniesi tali erano senza dubbio, anche se, come accade non di rado in organizzazioni del genere, qualcosa trapelava all’esterno.
Vi era certamente un livello più aperto, che si manifestava e si esprimeva nel contesto ludico del simposio.
E vi era un livello molto più delicato e molto meno aperto, dove si progettava, si tramava, si rivaleggiava e, se del caso, ci si tradiva, come avvenne nelle convulse giornate delle delazioni e contro-delazioni conseguenti agli scandali ‘sacrali’, ma in realtà politici, del 415.
Non deve sfuggire la precisione terminologica di Tucidide: per un verso parla di ‘eteri’ quando ad esempio riferisce la riunione dei congiurati in cui Frinico espone controcorrente i suoi dubbi, per altro verso quando parla di Pisandro in azione e proteso ormai all’organizzazione concreta della trama dice che costui visitò, ad Atene, una per una, “le congiure in atto”.
Pag. 270
Cap. 19. Frinico il rivoluzionario
I temi in discussione sembrano essere due: se ancorare le fortune dell’imminente azione eversiva al richiamo di Alcibiade riservando e riconoscendo dunque all’ingombrante esule un ruolo protagonistico; e se contare sull’automatismo del cambio di regime anche nelle città alleate una volta preso il potere in Atene.
Su entrambi i punti – nota Tucidide con ammirazione e consenso – Frinico vedeva più lontano degli altri.
E parlava chiaro (come del resto è normale, tra oligarchi, quando non si deve manovrare la retorica demagogica).
Agli altri sembrava plausibile, e da accogliere, l’offerta di Alcibiade: un accordo con la Persia in cambio del proprio rientro ad Atene purché non più in democrazia.
Frinico invece metteva in guardia.
Diceva – riferisce Tucidide come uno che è stato presente -: a me, Alcibiade non sembra affatto incline ad un regime piuttosto che ad un altro, l’unica cosa cui mira è di poter rientrare, in un modo o nell’altro, “chiamato dalla sua eteria (ypo ton etairon parakletheis) dopo aver rimesso in sesto la città dalla sua condizione attuale”.
E qui Tucidide inserisce un suo commento: “il che era vero!”.
Aggiungeva Frinico che anche l’argomento relativo agli intendimenti del Gran Re gli sembrava errato: “ormai che anche i peloponnesiaci erano sul mare ed avevano così numerose città sotto il loro dominio, era improbabile che il Gran Re spostasse il suo favore dalla parte degli ateniesi, dei quali comunque non si fidava, pur potendo invece farsi amici i peloponnesiaci, dai quali non aveva mai subito alcun danno”.
Parole molto significative, che evocano il rancore mai sopito in Persia nei confronti di Atene per il ruolo svolto nella rivolta della Ionia novant’anni prima.
Frinico passava quindi a spiegare – e Tucidide assicura che quelle furono esattamente le sue parole - che le città alleate oppresse dal governo popolare ateniese non avrebbero affatto scelto di restare più volentieri con Atene dopo il colpo di mano e l’instaurazione qui di un governo oligarchico: non vorranno “seguitare ad essere servi, ma dell’oligarchia (douleuein met’oligarkias) vogliono liberarsi e basta; e qui soggiunse quello che Moses Finley ha poi definito “il paradosso di Frinico”: “non dimentichiamo – disse – che l’impero fa comodo anche a noi e che gran parte dei nostri vantaggi materiali vengono appunto dall’impero”.
E disse anche qualcosa di più pungente vista la circostanza e l’ambiente in cui parlava: che la disaffezione degli alleati-sudditi sarebbe rimasta immutata anche dopo il cambiamento di regime giacché gli alleati-sudditi sapevano benissimo che dei crimini commessi dal regime democratico nei loro confronti erano stati per lo più istigatori e promotori proprio i ‘signori’ (i kalokagathoi).
Questa discussione in cui i partecipanti non hanno alcun bisogno di praticare la seduzione oratoria (non avendo davanti materia prima umana a cui destinarla) ma guardano la realtà in faccia, magari con una divisione di ruoli che si forma nel corso stesso della discussione, è molto simile a quella che si svolge nel più volte ricordato dialogo Sul sistema politico ateniese.
Pag. 281
Questo è un luogo tucidideo di straordinaria importanza.
Uno dei luoghi, oltre tutto, in cui Tucidide esprime direttamente le sue vedute politiche: il che gli accade più spesso del solito proprio in questo lunghissimo diario della crisi del 411.
(Si pensi alla netta valutazione positiva, come “primo vero buongoverno in Atene”, del governo terameniano dei Cinquemila).
Ma è straordinario questo luogo anche su di un piano più profondo, inerente alla concezione stessa della storiografia che Tucidide invera nell’empiria della scrittura.
Lo studio della politica vivente è per lui la sola vera forma di conoscenza storica: di qui l’accento posto sul valore esemplificativo degli eventi considerati nel loro stesso svolgersi rispetto alle diagnosi, e prognosi, di cui il vero, e dunque lungimirante, politico si dimostra capace.
Frinico ha visto ciò che gli altri non hanno voluto intendere sebbene messi sull’avviso.
E perciò andranno incontro al fallimento: l’esperienza di un governo finalmente non dominato dagli umori popolari e dalla necessità di assecondarli (cioè la democrazia) fallirà quando addirittura si staccherà l’Eubea dall’impero, e allora si correrà ai ripari liquidando il governo di Antifonte, Aristarco e compagni.
Esito che rappresenta una grande, ma sterile, vittoria postuma di Frinico (che nel frattempo era stato assassinato in circostanze mai del tutto chiarite).
Pag. 283-84
Cap. 20. Frinico cade e risorge: variazioni sul tema del tradimento.
Guillaume Guizot, l’abile ministro di Luigi Filippo, definiva il marchese di Lafayette “ornamento di tutte le cospirazioni”, poiché per circa mezzo secolo il suo nome veniva fuori puntualmente ad ogni cospirazione: ancora durante la Restaurazione quando vendite carbonare pullulavano negli ambienti militari ben dopo il ritorno del Borbone sul trono della Francia.
Alcibiade, rispetto alla crisi cronica e alle convulsioni della politica dalla pace di Nicia (421) al governo dei Trenta (404), potrebbe apparire il Lafayette della Repubblica ateniese.
Appena trentenne, nel 421, egli era l’uomo che tramava per far saltare la pace appena stipulata, due anni più tardi è il grande tessitore della fallimentare coalizione sconfitta a Mantinea, nel 415 è il principale sospettato nella tormenta degli scandali sacrali, ai quali non era certo estraneo, e che, nonostante il sarcasmo tucidideo sull’allarmismo patologico della mentalità democratica, una trama politica celavano.
Nel periodo trascorso a Sparta, e poi nell’entourage del satrapo Tissaferne, è riuscito a destare sospetti in tutti.
Nel 411 è al centro, come potenziale o ipotizzato complice più che come promotore, di tutte le manovre in atto.
E passa per essere l’uomo senza del quale non si può vincere, senza del quale la Persia continuerebbe ad essere ostile; e che però non rientrerebbe in città se non dopo un cambio di regime, comunque non – come mandò a dire ai congiurati – “sotto la democrazia, colpevole di avermi cacciato”.
Pag. 286
Mentre Alcibiade, ignaro del fallimento della sua contro-manovra, si affannava ad incrinare la fiducia di Tissaferne negli spartani, Pisandro sbarcava coi suoi uomini ad Atene.
Si presentava come messo dalla flotta di Samo e parlò davanti all’assemblea popolare: era pur sempre, nella considerazione corrente, un “demagogo” di lungo corso.
In sintesi il suo discorso fu: vi si offre la possibilità di avere il Gran Re come alleato e dunque di sconfiggere gli spartani, le condizioni sono: a) far rientrare Alcibiade, b) e perciò “far funzionare diversamente la democrazia”.
Questa formula è il gioiello, una vetta della mistificazione linguistica della parola politica.
Pisandro sta preparando la trama che ha come obiettivo l’abbattimento del regime democratico, ma deve catturare il consenso, e allora inventa la formula “ci vuole un’altra democrazia”, “non possiamo continuare a praticare la democrazia alla solita maniera”, se vogliamo che “Alcibiade rientri e ci porti l’’alleanza con la Persia”.
Pag. 288
Cap. 21. Morte di Frinico e processo al cadavere
Cap. 22. Il processo ad Antifonte
Riepilogando.
Il dato di partenza dev’essere quanto scrive Tucidide su quel memorabile processo, il cui verdetto era già scritto in partenza.
E Antifonte era il primo ad esserne consapevole.
Come pensare che smentisse puerilmente le proprie idee, che erano ben note ai suoi accusatori e visibili dai suoi comportamenti?
Come pensare che Tucidide, se davvero ebbe davanti un’apologia in cui Antifonte si scrollava di dosso ogni responsabilità nel colpo di Stato e ogni addebito si sentimenti anti-democratici, si spingesse, nello stesso contesto, ad additare in Antifonte il vero artefice del colpo di Stato e ad esaltare la sua apologia come “eccellente”, anzi insuperata?
Quella pagine di Tucidide è forse, insieme con la lunga riflessione sullo stile di governo di Pericle e il fallimento dei suoi successori (2., 65), tra le più importanti di tutta l’opera, e certo tra le più significative anche dal punti di vista della biografia dello storico.
Pag. 324
Cap. 23. Gli altri processi
Il “cambiamento” non significava affatto ritorno alla democrazia: anzi, i due punti qualificanti della nuova situazione erano agli antipodi della democrazia (solo 500 cittadini pleno iure e divieto categorico, ribadito con pene severissime per i trasgressori, del ‘salario’).
Il ‘salario’ era il simbolo stesso, il palladio, della democrazia, che i vecchi, caricaturali, del coro della Lisistrata giurano di voler difendere anche con le armi.
Dunque argine assoluto contro il ritorno al ’vecchio regime’ democratico.
E nondimeno per i capi del gruppo fino ad allora dominante – Antifonte, Pisandro, Acheptolemo, Onomacle, Aristarco, Alessicle – l’unica soluzione era fuggire a Sparta.
E’ evidente che paventavano una resa dei conti in cui, come sempre nella lotta politica ateniese, non ci sarebbero state mezze misure: o ammazzare o essere ammazzati.
Pag. 326
Cap. 24. La commedia di fronte al 411
E’ sapiente la parodia, in realtà assai vicina all’originale, del linguaggio politico del momento.
Lo si coglie nel diverbio Probulo-Lisistrata sull’amministrazione del tesoro e lo si coglie nell’attacco stesso con cui i vecchi lanciano il loro grido di allarme: “Chiunque è uomo libero non può starsene a dormire!”.
Non è affatto casuale che il coro dei vecchi adoperi un lessico politico in cui oligarchia e tirannide valgono come sinonimi.
Questo è un aspetto cruciale del linguaggio di parte democratica, di cui Tucidide ci dà due volte – in punti cruciali del suo racconto – capitale testimonianza, e che ha a che fare con la costruzione ideologica più forte della democrazia ateniese: l’auto-rappresentazione della democrazia come antitesi polare della tirannide.
Per cui la mentalità e la prassi oligarchica ricadono, per così dire, nell’ambito della ‘tirannide’, dell’aspirazione alla tirannide.
Il che non è totalmente svincolato dalla reale dinamica della lotta politica.
Tucidide stesso sa (e Aristotele ripete) che tra gli oligarchi scoppia ben presto la gara per cui “ciascuno vuol essere il primo”; e l’oligarca-tipo del celebre e acutissimo ritratto delineato da Teofrasto nei Caratteri va in giro ripetendo di continuo il verso omerico “uno sia il capo!”; così come – in quanto caposaldo della stessa politica – ripete il ritornello: “o noi o loro in città!”.
Nelle due occasioni in cui Tucidide parla di colpi di Stato ad Atene – quello paventato (e forse abortito) del 415 e quello, portato a compimento, del 411 – attribuisce alla coscienza popolare (“il demo pensando che etc.”, “il demo ricordando ciò che sapeva per tradizione orale, etc.”) il timore di una “congiura – come egli si esprime – oligarchica e tirannica”.
In questo caso riferisce pensieri correnti nel demo.
Commentando però l’exploit dei tre artefici della rivoluzione oligarchica – e dando in questo caso l’idea di parlare in prima persona – osserva che era impresa grande “togliere la libertà al demo a cento anni circa dalla caduta dei tiranni”.
In questo secondo caso sembra che egli faccia propria quella equiparazione oligarchia/tirannide che è l’ideologia di base del demo ateniese, confermata tra l’altro e ribadita annualmente negli epitafi.
In realtà a ben vedere la frase è volutamente ambigua.
Vi è infatti anche un altro modo di utilizzare il concetto di “libertà del popolo”: è quello, sommamente ostile, dell’opuscolo dialogico Sul sistema politico ateniese che denuncia come principale stortura del regime democratico il fatto che “il popolo vuol essere libero, anziché assoggettarsi all’eunomia”.
Ed è del tutto evidente, alla luce degli altri, espliciti, giudizi tucididei sulla irresponsabilità con cui il popolo fa uso della propria illimitata libertà d’azione in democrazia (poiein o ti bouletai), che proprio di questo Tucidide intende parlare.
La libertà che “sembrava impossibile togliere al demo dopo un secolo” è per l’appunto quel poiein o ti an doké, quel porsi al di sopra delle leggi che connota il ‘potere popolare’.
Ecco perché, quasi a completare il pensiero sulla libertà/arbitrio che i congiurati avevano finalmente spento, Tucidide prosegue osservando che quella ‘libertà’ del popolo ateniese era consistita essenzialmente nel dominio sugli altri: perché la del popolo ateniese viene a sostanziarsi della tirannia che esso esercita sugli altri.
Il coro dei vecchi, a sua volta, a sua volta, lancia l’allarme con uno straordinario attacco oratorio appellandosi a “chiunque vuol essere libero” e subito dichiara di temere la tirannide (“odore di Ippia”, “pugnale nel mirto”, “statua di Aristogitone”), per poi concretamente identificare la libertà nel misthos, che la tirannide appunto metterebbe in pericolo.
E’ un campionario perfetto del gergo democratico.
Resta senza risposta la domanda, legittima, se Aristofane stia semplicemente descrivendo l’allarmismo democratico o stia approfittando della scena comica per lanciare un allarme.
Pag. 338-340
E nello stesso tempo –dopo la rappresentazione dell’Oreste (408) – se ne va Euripide, della cui collaborazione in drammaturgia con Crizia si è detto a suo tempo.
Ovvio che non possiamo pretendere di leggere tra le righe in una tradizione biografica così inquinata come quella sedimentatasi intorno alla figura di Euripide.
Rispetto a tale tradizione è di per sé molto più importante il fatto che Aristofane lo prendesse di mira ancora più che lo stesso Socrate.
Mentre è fatica sprecata cercare di incasellare Euripide in una delle correnti democratiche ateniesi, ha più senso rilevare come il radicalismo della sua critica del costume lo collochi in quell’area intellettuale di critici radicali delle convenzioni su cui la città democratica poggia che poté vedere nella presa del potere da parte di dottrinari alla Antifonte e Crizia o di miscredenti della democrazia come Teramene un fatto positivo.
Salvo a rimanere delusi, come dice Platone di sé al principio della lettera settima.
Non può essere un caso che, volendo, nelle Rane, indicare gli ‘allievi’ di Euripide, Aristofane abbia indicato in Teramene e Clitofonte.
Clitofonte – cui si intitola un dialogo platonico avente come oggetto la giustizia! – è colui che, nel 411, aveva ulteriormente appesantito il decreto di Pitodoro che mise in moto la procedura di nomina dei Quattrocento, con un ulteriore decreto che ordinava di riesaminare le leggi note come di Clistene in quanto la ‘vera’ costituzione di Clistene non era democratica ma, semmai, soloniana.
Crizia, Teramene, Clitofonte (che riapparirà puntualmente nel 404): se questo è il milieu intellettual-politico di Euripide, non è difficile comprendere perché l’atmosfera della aggressiva restaurazione democratica del 409 gli possa essere parsa irrespirabile.
Aristofane invece, nonostante tutto, a quel che sappiamo, rimase.
Gli ispiravano antipatia i leaders democratici; ma neanche questi dottrinari, la cui ‘coerenza’ poteva diventare omicida, erano nelle sue corde.
Uno che, dopo l’anno terribile degli scandali sacrali e delle persecuzioni giudiziarie e dei tradimenti di tutti verso tutti, scrive gli Uccelli (414) non ha palesemente fiducia né negli uni né negli altri.
Pag. 349-50
Parte quinta. Tra Alcibiade e Teramene
Cap. 25. Una verità dietro due versi
Cap. 26. Il ritorno di Alcibiade
Il ritorno della democrazia ridiede slancio alla città, e soprattutto segnò il ricongiungimento della flotta, ormai agli ordini di Alcibiade, con i cittadini, dopo la separazione determinatasi a seguito della presa di potere da parte dei Quattrocento.
Alcibiade era dunque rientrato nel generale convincimento che egli fosse l’unico possibile restauratore della potenza ateniese.
Nelle fonti che parlano di questi avvenimenti ritorna frequentemente l’espressione “il solo” (monos).
Ma, come vedremo, l’accordo tra Alcibiade e i suoi concittadini durò poco.
Per intanto si produsse un fenomeno altrettanto inaudito quanto l’attribuzione dei pieni poteri ad Alcibiade.
Gente umile, “i poveri” – riferisce Plutarco – si recavano insistentemente nella dimora di Alcibiade e gli chiedevano di assumere “la tirannide”.
Plutarco, che ci dà questa importante notizia – assente, ovviamente, negli appunti tucididei messi in ordine da Senofonte – dice esattamente che questa massa di poveri “era presa dalla smania incredibile (eran erota thaumaston) di essere sotto la sua tirannide”.
Non solo: lo incitavano ad abrogare leggi e decreti e politici professionali (li definivano “i chiacchieroni”) responsabili di “mandare in rovina la città”.
Questo è uno squarcio di realtà che, senza la capacità di Plutarco di dar conto delle sue immense letture, sarebbe andato smarrito.
Ed è sommamente istruttivo: perché dimostra ancora una volta, quasi in ideale ricongiungimento all’esperienza di Pisistrato, la vicinanza, almeno dal punto di vista della base sociale, tra democrazia e tirannide.
Ma c’è qualcosa di più: quell’attacco ai “chiacchieroni” rovinosi per la città sta ad indicare che, a vent’anni ormai dalla morte di Pericle (princeps secondo Tucidide e ‘tiranno’ secondo il comici), la fiducia nel ceto politico si era logorata.
Perlomeno tra i ceti più poveri: consapevoli dell’inganno ‘democratico’, del loro non contar nulla nonostante il meccanismo apparentemente egualitario dell’assemblea, essi cercano ormai di saltare la mediazione del ceto politico che li ha delusi, e puntano ad un nuovo ‘tiranno’ di loro fiducia.
Un ciclo della storia politica ateniese si stava chiudendo.
Plutarco commenta giustamente (35, 1) chenon riusciamo a cogliere “cosa veramente Alcibiade pensasse della tirannide”.
E si limita a notare la paralisi degli altri politici dinanzi ad un tale pericoloso trionfo, protesi perciò a liberarsi di lui: “che riprendesse il mare al più presto”; e gli concessero anche, cosa inaudita ma rientrante nei ‘pieni poteri’, di “scegliersi i colleghi che voleva”.
Ed è per questo che, di lì a poco, l’insuccesso a Notion di un suo subordinato determinerà la sua mancata rielezione ed il suo nuovo ritiro dalla scena.
Non aveva osato compiere quel passo audacissimo, forse troppo azzardato, che gli veniva proposto; aveva pensato di affidarsi al ‘metodo’ di Pericle di puntare comunque alla rielezione annuale: e perciò lo si poté colpire al primo insuccesso [paragone con Matteo Renzi].
Ma per un momento non breve la posizione raggiunta gli era parsa tale da non esigere la esplicita assunzione della tirannide.
Un grande poligrafo ottocentesco che ha dedicato ad Alcibiade una mirabile e appassionata biografia, Henry Houssaye, ha descritto bene questa perplessità di Alcibiade: “nominato generale con pieni poteri su tutto l’esercito sia di mare che di terra, padrone della politica interna e della politica estera, acclamato all’assemblea ogni volta che vi appariva, idolatrato dal popolo, temuto da tutta la Grecia non meno che del re di Persia, non aveva forse già in pugno poteri sovrani? Consacrato dittatore (autokrator) dalla volontà popolare perché avrebbe dovuto tradirla per farsi tiranno? Investito dalle leggi di pieni poteri perché avrebbe dovuto violarle?”.
Pag. 263-64
Cap. 27. Il processo degli strateghi
Cap. 28. Teramene uno e due
A questo punto comincia ad essere evidente al lettore che intorno alla figura di Teramene si è aperta una battaglia, politica e poi storiografica, che è cominciata vivente lui medesimo; e che è andata avanti almeno fino alla ‘codificazione’ aristotelica della storia costituzionale di Atene, dove spicca quell’inquietante capitolo ventottesimo culminante in una specie di plaidoyer, di Aristotele, in difesa di Teramene “modello del buon cittadino”.
Inquietante è quel capitolo per varie ragioni, non ultima la esclusione di Pericle dal novero dei ‘buoni politici’ e l’inclusione – invece – di Tucidide, figlio di Melesia, suo sfortunato avversario, tra i tre in assoluto migliori (beltistoi): accanto a Nicia e a Teramene.
In parte avrà pesato in questa scelta l’influsso della dura valutazione platonica nei confronti di Pericle.
Ma questo non basta a spiegare la singolarità di quel capitolo.
Tra l’altro Teramene è del tutto assente dal ‘mondo di Platone’ e anzi ci si stupirebbe di trovarcelo dato il legame mai sconfessato – anzi dichiarato e valorizzato in un dialogo che porta il suo nome – di Platone con Crizia.
Pag. 373
Che dunque Teramene sia stato al centro di una discussione politico-storiografica di enorme rilievo – che investiva i momenti decisivi del dramma ateniese (la pace coatta divenuta resa incondizionata; la seconda oligarchia e la guerra civile) – è dimostrato dalla diametrale opposizione tra i sue trattati di Teramene che emergono dalle fonti nonché dalla violenza polemica degli assertori dei due opposti profili.
Violento è il dettagliato ritratto che Lisia inserì nel Contro Eratostene; appassionata, e ben lontana dalla abituale freddezza è l’apologia che ne fa Aristotele (e già Eforo).
E fonti riemerse per caso dal naufragio delle letterature antiche, per esempio il cosiddetto “Papiro Michigan di Teramene”, ci permettono di constatare che motivi di bruciante polemica presenti nelle parole di un testimone oculare quale Lisia (“gli altri usano il segreto contro il nemico, Teramene l’ha adoperato contro di voi”) ritornavano nella storiografia: da un’opera di storia infatti proviene quel frammento di papiro.
Lì veniva data la parola a Teramene, il quale con efficaci argomenti difendeva la sua linea: condurre una trattativa nascondendone i contenuti ai suoi concittadini.
Ma era difficile per lui sottrarsi alla taccia di aver preteso fiducia incondizionata per poi mandare alla rovina la città che si era messa, disperatamente, nelle sue mani.
Lisia su questo punto è perentorio, ma ancor più duro – pur senza il ricorso a toni sopra le righe ed anzi in stile secco e oggettivo – è il resoconto della condotta di Teramene, in quei mesi, racchiuso nel secondo libro delle Elleniche.
Di tale narrazione, il punto di partenza è la disastrosa battaglia navale di Egospotami (estate 405), il punto di arrivo è la capitolazione di Atene e la distruzione delle mura (aprile 404); di mezzo l’assedio e la strenua resistenza di Atene – durata quasi nove mesi – al blocco spartano dopo la perdita dell’ultima flotta.
Il clima da feroce resa di conti in cui la guerra volge al termine è chiaro già dal modo in cui Lisandro, vincitore ad Agospotami forse grazie al tradimenti, tratta i vinti: tranne il generale fellone, Adimanto, unico prigioniero che Lisandro risparmia, tutti gli altri vengono passati per le armi.
Il tradimento è, come si sa, parte essenziale della guerra.
Sono le “anime belle” inorridiscono di fronte alla necessaria sospettosità di grandi leaders che hanno dovuto fare i conti con l’ossessione del tradimento.
“Non vi è faccenda che non richieda l’utilizzo di spie” insegna il maestro Sun Tzu nel 13. capitolo dell’Arte della guerra
Pag. 376-77
Intermezzo
Cap. 29. Gli spartani non esportarono la libertà: Isocrate contro Tucidide
Parte sesta. La guerra civile
Cap. 30. Atene anno zero: come si esce dalla guerra civile
Ad Atene ancora una volta fu un’assemblea popolare ad abbattere la democrazia.
Sotto gli occhi di Lisandro e con in casa gli spartani in armi, l’assemblea elesse i Trenta: una magistratura straordinaria che aveva il compito di scrivere una nuova costituzione.
Furono scelti gli oligarchi più in vista.
Tra gli altri Teramene che, secondo Lisia, fu addirittura il promotore della proposta.
Ma questa volta il “coturno” sarebbe stato presto liquidato da uomini, come Crizia, più spregiudicati e forse anche protesi, a differenza di Teramene, verso una impossibile rottura col passato di Atene.
Così ebbe inizio il truce regime dei Trenta.
Pag. 394
Cap. 31. Dopo la guerra civile: la salvazione individuale, 401-399 a. C.
Ecco perché Senofonte non fu presente al processo di Socrate.
Né stupisce che Socrate gli avesse sconsigliato di andarsene da Atene.
Giacché Socrate per se stesso, quando venne il suo turno, decise appunto in quel modo: di non salvarsi andandosene da Atene, il che fino all’ultimo, come sappiamo dal Critone platonico, gli sarebbe stato pur possibile.
Senofonte ha fatto dunque, disobbedendo a Socrate, quello che Socrate non ha voluto fare: si è sottratto alla giustizia della sua città.
Certo la sua posizione doveva essere piuttosto seria: poiché la condanna fu l’esilio, il reato doveva essere di sangue; e sappiamo che l’amnistia del 403 non valeva per questi reati (Aristotele, Costituzione degli ateniesi, 39, 5).
Il che spiegherebbe la scelta di ritirarsi ad Eleusi, e quella conseguente di scomparire nell’armata di Ciro quando la repubblica oligarchica di Eleusi fu sopraffatta a tradimento.
Anche per Socrate si trattava di un tardivo contraccolpo della guerra civile: per lui “era rimasto in città”, come si disse allora di coloro non si erano uniti ai democratici del Pireo, e che, soprattutto, era noto per aver “educato” Crizia, come gli fu rinfacciato post mortem in un libello di successo ed ancora tanti anni dopo da Eschine in un discorso giudiziario di grande risonanza (1., 173).
La sua memoria non ci è stata forse serbata da quei giovani “ricchissimi” della cui frequentazione egli si vanta nell’Apologia platonica (23c)?
Dunque il processo contro di lui nell’anno 399, un anno ricco di processi apertamente dissonanti con la lettera e lo spirito dell’amnistia, rientrava in quella resa dei conti che è spesso il prolungamento più penoso di una guerra civile.
Pag. 411
Cap. 32. Dopo la guerra civile: il dibattito costituzionale
Se le cose stanno in questo modo si chiariscono vari punti.
Innanzitutto svanisce l’idea che ci sia stata una proposta limitativa della cittadinanza ancorata al requisito di “possedere terra”.
Nella lunga storia ateniese della lotta intorno al possesso della cittadinanza questo sarebbe un unicum contrastante con il criterio base ogni volta riproposto.
Invece una volta inteso rettamente il senso del primo discorso si comprende che, in quelle assemblee cui fa cenno anche Aristotele, qualche proposta punitiva ultra-democratica era stata avanzata per escludere i grandi proprietari terrieri, cioè il ceto più ricco (nello spirito del discorso sui “cani alla catena”), e che il primo parlante di questa coppia di discorsi ha contrastato l’iniziativa argomentando che c’erano stati anche ricchi proprietari ‘patrioti’.
E il parlante potrebbe essere, in tal caso, proprio Formisio, il cui nome Dionigi trovava attestato come protagonista di questa vicenda.
Pag. 421
Naturalmente non sappiamo perché, nel rotolo di cui Dionigi disponeva, questo discorso di Formisio stesse insieme ad un testo, di opposto orientamento, attribuito a Lisia.
Probabilmente Lisia si era espresso, o in forma di pamphlet o con una vera demegoria (nei primi giorni del rientro degli esuli nessuno poteva impedire ad uno dei finanziatori di Trasibulo di parlare all’assemblea, ancorché meteco: quale che sia l’esatta data del decreto di Trasibulo che estendeva la cittadinanza), ed aveva svolto quegli argomenti radical-patriottici che leggiamo nei capitolo 6-7.
E poiché il suo bersaglio era il discorso moderatissimo e subalterno agli spartani che Formisio aveva pronunciato in quella occasione i due testi furono, ad un certo punto, accorpati.
Il discorso del secondo parlante (cioè Lisia) rispetto all’altro parlante (Formisio) sembra vertere non tanto sul merito della proposta cui Formisio si oppone ma sulla subalternità nei confronti degli spartani: che Formisio sapeva benissimo essere stati, Pausania in odio a Lisandro, artefici della liquidazione del governo oligarchico e dunque della restaurazione dell’ordinamento preesistente.
(Ma magari a Pausania sarebbe piaciuta una moderata patrios politeia, mentre Trasibulo e Lisia e molti altri pretesero la democrazia pienamente restaurata).
Perciò il nocciolo degli argomenti svolti dal secondo parlante è: non dobbiamo accettare alcuna tutela spartana e, se necessario, siamo pronti a contrastare anche loro (palese insensatezza estremistica).
Ma questa impostazione non è forse quella che Aristotele nel suo breve cenno dice che si affermò e fu assunta come premessa per la piena restaurazione democratica?
“Il popolo si è liberato con le sue sole forze”, dunque non siamo debitori di nulla a Pausania e agli spartani.
E’ questa l’impostazione del secondo parlante, è questo il suo punto di forza: agevolò nettamente la restaurazione democratica, anche se, ovviamente, la proposta di ridurre all’atimia i proprietari perché tradizionali sostenitori dell’oligarchia fu certamente accantonata.
Probabilmente anche per merito di Formisio.
Pag. 422-23
Parte settima. Uno sguardo sul 4. secolo
Cap. 33. Corruzione politica
Poiché la maggior parte dell’oratoria attica superstite è del 4. secolo, è comprensibile che per tale epoca noi siamo largamente informati sul fenomeno della corruzione politica in ogni suo aspetto.
Grandi e monumentalizzati oratori protagonisti della politica si scambiano, su tale terreno, le accuse più pesanti in un intreccio, per noi spesso inestricabile, di falso e di vero.
E determinante è ovviamente lo schieramento, il punto di vista.
Dal punto di vista dei gruppi politici favorevoli al predominio macedone, la politica demostenica è “al soldo della Persia”.
Eschine (Contro Ctesifonte, 156 e 239) e Dinarco (Contro Demostene, 10 e 18) sono espliciti, anche se si riferiscono soprattutto all’epoca successiva a Cheronea (338 a. C.).
Ma nulla autorizza a pensare che prima della sconfitta di Cheronea le cose andassero diversamente.
Una tradizione storiografica, evidentemente filomacedone, forniva anche i dettagli sull’argomento: Alessandro avrebbe trovato a Sardi, dopo la caduta dell’impero persiano e la conquista degli archivi persiani, le lettere del re di Persia con cui i satrapi della Ionia ricevevano l’ordine di sostenere Demostene in ogni modi e di versargli somme colossali (Plutarco, Vita di Demostene, 20, 4-5).
Il re di Persia era consapevole della minaccia rappresentata dalle mire macedoni e dalla aggressività di Filippo, e perciò pagava Demostene perché fomentasse l’opposizione contro Filippo in Grecia.
Plutarco, il quale qui potrebbe dipendere da Teopompo, forse dal suo durissimo e implacabile libro sui “demagoghi ateniesi”, inserito quale digressione nelle Storie filippiche, precisa anche che Alessandro trovò, negli archivi persiani, una documentazione completa: non solo le lettere del re di Persia ai satrapi, ma anche le lettere di Demostene, evidentemente indirizzate ai suoi interlocutori persiani, e addirittura i rendiconti dei satrapi, attestanti l’entità delle somme versate all’oratore ateniese.
Non abbiamo tracce altrettanto circostanziate dell’analogo rapporto esistente tra il re di Macedonia e gli avversari di Demostene: quegli avversari – Eschine e Filocrate per esempio – cui Demostene rinfaccia continuamente di essere “pagati” dal sovrano macedone e di agire perciò, nella scena politica ateniese, sempre e soltanto nell’interesse del sovrano macedone.
Ma non abbiamo ragione di dubitare che anche Demostene dica il vero quando batte, ossessivamente, su questo tasto.
Ovviamente, nessuno dei due schieramenti agisce alla luce del sole come rappresentante degli interessi dell’una o dell’altra grande potenza: il sostegno viene dato in modo indiretto.
Il compito di Eschine e dei suoi amici è quello di smorzare l’allarme che Demostene e i suoi lanciano senza soste contro le mire macedoni: Eschine ed i suoi tendono a dar apparire quello di Demostene coem un allarmismo infondato; e quando l’attrito si fa evidente ed è impossibile negare l’ostilità di Filippo verso Atene, tendono in tutti i modi a dimostrare che è la politica provocatoria di Demostene e dei suoi che ha portato la situazione al punto di rottura.
Al tempo stesso si sforzano in tutti i modi di far emergere che Demostene in tanto si schiera per la rottura frontale e senza mediazioni nei confronti della Macedonia, in quanto lavora per il re di Persia: non dunque per quell’esasperato e sempre ostentato patriottismo che occupa tanta parte dei suoi discorsi.
Pag. 424-25
E’ evidente l’ottica faziosa con cui la fonte di Plutarco presenta il fenomeno Pericle.
Una politica di lavori pubblici che ha come fine ‘sociale’ un salario ai nullatenenti diviene – in quest’ottica – uno strumento di corruzione generalizzata.
E vengono messi insieme fenomeni tra loro diversi: la politica di opere pubbliche, la voglia di arricchirsi da parte degli architetti che quelle opere siressero, il ‘salario’ ai frequentatori del teatro, la moltipilcazione delle occasioni festive, in quanto occasioni ‘demagogiche’.
Anche il dialogo Sul sistema politico ateniese deplora: “Gli ateniesi celebrano il doppio di feste rispetto agli altri”.(3., 8).
Occasioni demagogiche, le feste, in quanto, oltre tutto, momento adatto al consumo gratuito di carne: cibo costoso, per i non benestanti.
Pag. 427
Una magistratura i cui comportamenti venivano costantemente scrutati e sottoposti al controllo era, comprensibilmente, quella da cui maggiormente dipendevano le sorti della città: la strategia.
Magistratura elettiva (insieme con l’ipparchia), era riservata di fatto ad esponenti delle più alte classi di censo (pentacosiomedimmi, cavalieri).
Questo spiega perché quelle due magistrature sono costantemente ‘sotto osservazione’: non solo per la estrema delicatezza del ruolo, per l’enorme potere che esercitano, ma anche per il tipo di persone agli occhi popolari sempre sospette, che le riveste.
Pag. 430
Cap. 34. Demostene
Ma una “tregua sociale” i proprietari la ottennero soltanto sotto la dominazione macedone: una delle clausole principali della “pace comune” stipulata tra Filippo e gli Stati greci (338) e confermata nel 336 da Alessandro impegnava tutti gli Stati e le città contraenti ad impedire “esilii, confische di beni, suddivisioni di terre, remissioni di debiti, liberazione di schiavi a fini sediziosi”.
Anzi, il trattato del 338 fu preso a base non solo nel 336 ma anche nel 319, su iniziativa di Filippo 3. e Poliperconte, e nel 302 con Demetrio Poliorcete e Antigono Monoftalmo.
Ed è interessante osservare il tono di grande rispetto con cui Filippo, nella Lettera agli Ateniesi tramandata nella raccolta demostenica, parla “dei cittadini più ragguardevoli” (gnorimotatoi) delle città greche, perseguitati dai sicofanti che vogliono ingraziarsi il demo (12., 19): si può anzi osservare che qui Filippo adopera termini tecnici della lotta politico-sociale degli Stati greci.
Pag. 440
Cap. 35. Epilogo: dalla democrazia all’utopia
La democrazia e l’impero erano nati insieme.
Temistocle che porta Atene alla vittoria, a Salamina, genera l’una e l’altro: e la sua intuizione di munire immediatamente la città di un potente sistema di mura, superando con l’inganno le resistenze e l’opposizione spartana, suggella, col necessario strumento difensivo, il successo conseguito e pone le premesse per il futuro conflitto con Sparta.
Quelle mura costituiscono il ‘palladio’ tanto della democrazia quanto dell’impero, e formalizzano la rottura degli equilibri fino allora incentrati sulla indiscussa egemonia spartana sull’intero mondo greco.
Del resto la pretesa spartana di impedire ad un’altra città, Atene, di munirsi di mura denota di per sé che de facto la prevalenza di Sparta interferiva fin nella vita interna delle altre comunità.
Il conflitto era cominciato sin da subito.
E’ formalistico delimitare il periodo di guerra al trentennio finale del quinto secolo: in un crescendo, quel conflitto ha inizio con la nascita stessa delle mira.
E le mura saranno, al momento della capitolazione di Atene (404), il principale bersaglio dei vincitori e l’oggetto di disperata e vana difesa da parte dei vinti.
E la rinascita di quelle mura nel 394 segnerà il nuovo inizio di una seconda, e meno durevole ma a suo modo produttiva, nuova avventura imperiale.
Pag. 451
A ben vedere, tutta l’opera di Platone, là dove affronta direttamente il problema politico (la Repubblica è il documento più grande ma non certo l’unico), presuppone che l’impero non c’è più e che il conflitto sociale non conosce soste e raggiunge vertici di asprezza: donde la necessità di trovare una soluzione totalmente nuova, più profonda, del problema politico, che si intreccia indissolubilmente con la conflittualità sociale.
Portando alle estreme conseguenze la questione, Aristotele, nel terzo e nel quarto libro della Politica, perverrà alla perfetta identificazione tra forme politiche e gruppi sociali e formulerà l’identificazione compiuta democrazia = dominio (governo) dei poveri versus oligarchia = dominio (governo) dei ricchi, indipendentemente dalla consistenza numerica dei due gruppi contrapposti.
Pag. 452
Non era la prima volta che Senofonte si impegnava nella riflessione sul miglior ordinamento.
Per la gran parte della sua vita egli era rimasto fermo nella persuasione della superiorità dell’eunomia spartana su ogni altra forma di ordinamento politico e sociale.
E aveva conformato, cosa rara, le sue scelte di vita a tale convincimento.
Se fino alle guerre persiane Sparta era stata indiscutibilmente la grande potenza nonché il modello di comunità incentrata sull’armata di terra e sulla identità cittadino-guerriero (non dissimile è ancora l’Atene di Milziade), con l’irrompere della flotta ateniese e quindi dell’impero e quindi della democrazia quel kosmos spartanocentrico si era spezzato.
Si era infranto e aveva prodotto uan sequela di guerre e conflitti: fino a quello interminabile ed efferato e alla catastrofe finale.
Tutto ciò era parso a molti, e a Senofonte in primis, una conferma della gravità dell’errore di partenza: essersi discostati dall’eunomia.
Il ‘credo’ senofonteo di questi anni, culminati nella sua partecipazione diretta alla guerra civile dalla parte oligarchica, è racchiuso, e retrospettivamente riaffermato, nella sua Costituzione degli spartani.
A Sparta – egli osserva – è addirittura vietato il possesso dell’oro e il valore principale è l’obbedienza ai magistrati: anche i potenti visi adeguano (cap. 8)!
Pag. 457
La questione sociale domina il quarto secolo come domina l’oratoria demostenica: anche quando l’oratore sembra parlar d’altro.
Quando c’era l’impero, il conflitto si svolgeva all’interno della ‘gilda’ per dirla ancora con Weber, e aveva come posta in gioco la redistribuzione del bottino.
Perduto l’impero una prima e seconda volta, la immediata reazione dei ceti più forti è stata quella di tentare di ridurre la cittadinanza.
Negli anni che intercorrono tra il decollo dell’avventura politica di Demostene, proteso a trovare per la sua città spazio per una terza ‘egemonia’ (magari nell’orbita della Persia), e la disfatta definitiva del 322, cioè nel corso di un trentennio, si consuma ancora una volta lo scontro sociale che non conosce soste.
E quando i benestanti avranno i macedoni come garanti della sconfitta dell’ultima reincarnazione della democrazia imperiale, per prima cosa ridurranno il corpo civico a novemila cittadini, sulla base del censo e su esplicita sollecitazione di Antipatro.
E’ l’Atene di Focione a sovranità limitata.
Ed è l’inizio di un declino che non conoscerà soste.
Al tempo di Cicerone e di Posidonio di Apamea, al tempo di Silla in guerra contro Mitridate, sarà il governo del filosofo e politico Atenione.
Posidonio, di cui si è salvata una pagina in cui si narra quella vicenda, non esita a ridurre, con inusitata ferocia, il mito della grande Atene – che parla per bocca di Atenione, caricatura di Demostene – ad una farsa: “Basta con il templi sbarrati, i ginnasi abbandonati, il teatro deserto, muti i tribunali e la Pnice, sacra agli dei, priva del demo!”.
Questo dice il demagogo, nella derisoria parafrasi del filosofo di Apamea, cliente dei potenti romani.
Atene era ormai, per lui, come per Cicerone, il luogo della “nimia libertas”, ora ridotta in farsa.
E per essa, a loro giudizio, era finita.
Pag. 462-63
Bibliografia
La democrazia realizzata / Hans Bogner
Democrazia / D. Musti
Atene: la costruzione della democrazia / G. Camassa
Storia greca / H. Berve. – Laterza, 1966
Storia della civiltà greca / J. Burckhardt. – Sansoni, 1955
Storia dei greci / G. De Sanctis. – La Nuova Italia, 1939
Economia e società / M. Weber. – Ed. di Comunità, 1974
Storia economica: linee di una storia universale dell’economia e della società / M. Weber. – Donzelli, 1993
La lega ateniese del sec. 4. a. C. / S. Accame. – Signorelli, 1941
Storia delle finanze greche dai tempi eroici fino all’inizio dell’età greco-macedonica / A. M. Andreades. – Cedam, 1961
Il partenone / M. Beard. – Laterza, 2004
Polis: un modello per la cultura europea / G. Cambiano. – Laterza, 2000
Gli architetti del Partenone / R. Carpenter. – Einaudi, 1979
L’imposizione progressiva nell’antica Atene / G. Gera. – 1975
Frinico fra propaganda democratica e giudizio tucidideo / G. Grossi. – 1984
Filippo il macedone / A. Momigliano. – Le Monnier, 1934
Rapporti di forza: storia, retorica, prova / C. Ginzburg. – Feltrinelli, 2000
Machiavelli e gli storici antichi: osservazioni su alcuni luoghi dei discorsi sopra la prima deca di Tito Livio / M. Martelli. – Salerno, 1998
La città e l’uomo: saggi su Aristotele, Platone, Tucidide / L. Strauss. – Marietti, 2010
Studi sull’Athenaion politeia pseudosenofontea / L. Canfora. – In: Atene e Roma 29, 1984
Commento all’Athenaion Politeia dello pseudo-Senofonte / W. Lapini. – 1997
La costituzione degli ateniesi dello pseudo-Senofonte / G. Serra. – 1979
Aristofane: introduzione alle commedie / J. G. Droysen. – Sellerio, 1998
Commedie di Aristofane / G. mastromarco. – Utet, 1983-2006
Aristofane autore di teatro / C. F. Russo. – Sansoni, 1962
Lisia: difesa dall’accusa di attentato alla democrazia / a cura di D. Piovan. – Antenore, 2009
Memoria e oblio della guerra civile: strategie giudiziarie e racconto del passato in Lisia / D. Piovan. – ETS, 2011